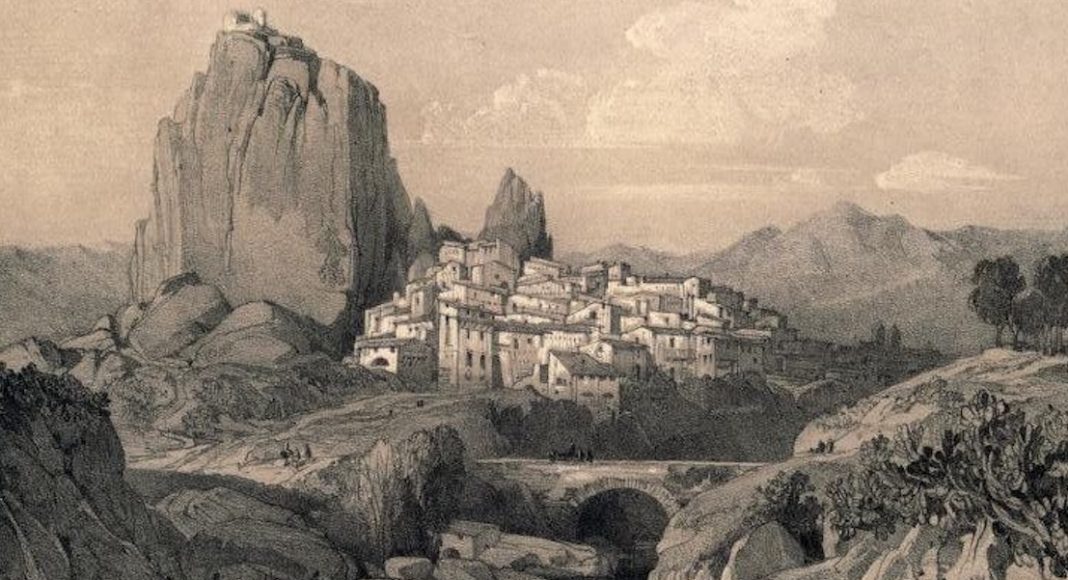Descrivere il territorio non fa parte delle mansioni per l’assessorato al turismo: spesso la letteratura italiana contemporanea confonde gli spazi e si lancia in consigli enogastronomici, guide a percorsi storici, riscoperte dei borghi e lunghi elenchi delle migliori pizzerie di Napoli, usando la trama come un albero spoglio per addobbi.
Soprattutto il Sud sembra essere diventato un’enorme sagra di street-food, aperta ventiquattr’ore al giorno. Al contrario, conoscere il meridione e saperlo annusare, gustare e identificare i suoi venti, lo consegna alle pagine dei libri per poter essere scoperto, ma soprattutto capito.
Scrivere di un territorio serve a leggerlo, nel suo passato, presente, e più di tutto, futuro.
Questa, da sempre, è la missione letteraria di Gioacchino Criaco, che riporta il riflettore sull’Aspromonte con il nuovo romanzo Il custode delle parole (Feltrinelli, 2022, pp.208).

Un racconto che ha l’ambizione di inondare le secche dei torrenti calabresi, non solo per ripristinarne il ciclo naturale con i suoi campi e frutti gialli, ma per riportare le narrazioni di un popolo esattamente dove erano nate: lungo i fiumi, in cui generazioni di pastori coltivavano la terra e tramandavano storie, usi e consigli perché “gli orti intorno erano un covo di nonni e nipoti, di favole e fatica, una nave corsara imbattibile. Un mondo verde che scorreva al ritmo della corrente fra sudore e frescura“.
Un corso virtuoso di uomini e natura da rifondare, partendo dalla lingua. Quel grecanico dimenticato dai figli che sovverte il destino dell’Aspromonte partendo proprio dall’etimo – non più aspro, ma “monte bianco” – , e riconsegna il futuro negato dal dialetto calabrese per affidarlo ai suoi discendenti: parlare nuovamente di un tempo prossimo dona anche la possibilità di programmarlo, “perché se a un popolo rubano le parole, quel popolo è morto“.
Un futuro che Andrìa, quasi trentenne, sta cercando di scrutare, non avendo ancora deciso, come avrebbe detto Gabriele Salvatores in Mediterraneo (1991) , “se mettere su famiglia o perdersi per il mondo“.
Se la Calabria facilmente demolisce ambizioni, anche la società lontana dalla Locride si prodiga in sfruttamento e dispersione identitaria nella giostra capitalistica: lavorare in abuso per non intrecciare le braccia e cedere allo stato di disoccupazione.
Così il ragazzo trascorre il tempo in un limbo, sempre indeciso tra l’andare o il restare, tra call center, bagno al mare con la fidanzata Caterina – un personaggio che sembra nascere dall’eroicità di Antigone di Jean Anouilh – le cure della madre e un nonno, Andrìa come lui, fiero pastore e custode dell’Aspromonte, che cerca di deragliare coscientemente il corso della vita del nipote, come il letto di un fiume. Tutto questo fino all’arrivo dal mare del libico Yidir.
È una società edipica e senza radici quella descrive Criaco: i padri – come quelli di Andrìa e Yidir – si dissolvono e scompaiono nei deserti, portando con loro le leggi e il buonsenso che deve dominare la misura dei rapporti tra umano e natura.
È saltato un equilibrio, un sistema di contrappesi su cui reggere il mondo: “il lavoro non è mai solo lavoro, anzi il lavoro non esiste, è l’unione dell’uomo con la terra in un rapporto carnale ma anche di spirito“. Dal recupero di questa unione occorre partire per trovare un’armonia perduta: Criaco esplora le possibilità dell’Aspromonte per un domani diverso, affascinato dal fantastico ma senza rinunciare alla concretezza, proprio perché abituato a seguire una logica lontana dal liberismo ormai diventato di tradizione.
Lo scrittore è guidato non solo da una percezione antica della natura – che sa leggere i segni nei colori, gli odori, la terra e l’ombra di sale sui vestiti bagnati dal mare – ma soprattutto da una lingua, il grecanico, che sa restituire la giusta collocazione alle cose tramite il loro nome.
“Parlo come penso“, fa lui, “le cose le devo sentire. Il latte dei miei animali non caglia se non sta dentro un bàgani, e il mio corpo non si riposa se non sopra un màtracho e con addosso una carpìta. E ora dimmi se ci sono le mie fuscelle di ligunìa, che solo dentro ta taddharìda di giunco la mia ricotta riesce a colare“.

Se per Rosa Luxemburg “il primo atto rivoluzionario è chiamare le cose con il loro nome“, per Criaco è invocarle con l’antica lingua dei padri, per donare un futuro.
Consegna al lettore un dizionario minimo dell’Aspromonte, Gioacchino Criaco con Il custode delle parole: un universo che non scade nella narrazione stereotipata, quasi turistica e non sorvola sulle difficoltà del presente come sulle prossime sfide.
Un romanzo in cui il lamento del pastore, una filosofia di vita, dialoga e si scontra con la razionalità di chi i monti ha voluto abbandonarli per poter crescere i figli, lontano da una povertà annunciata. Una storia che è anche manifesto di una speranza, in cui Criaco lascia un’ultima pagina bianca: che sia utopia o realizzazione un futuro diverso sta solo ai calabresi deciderlo.