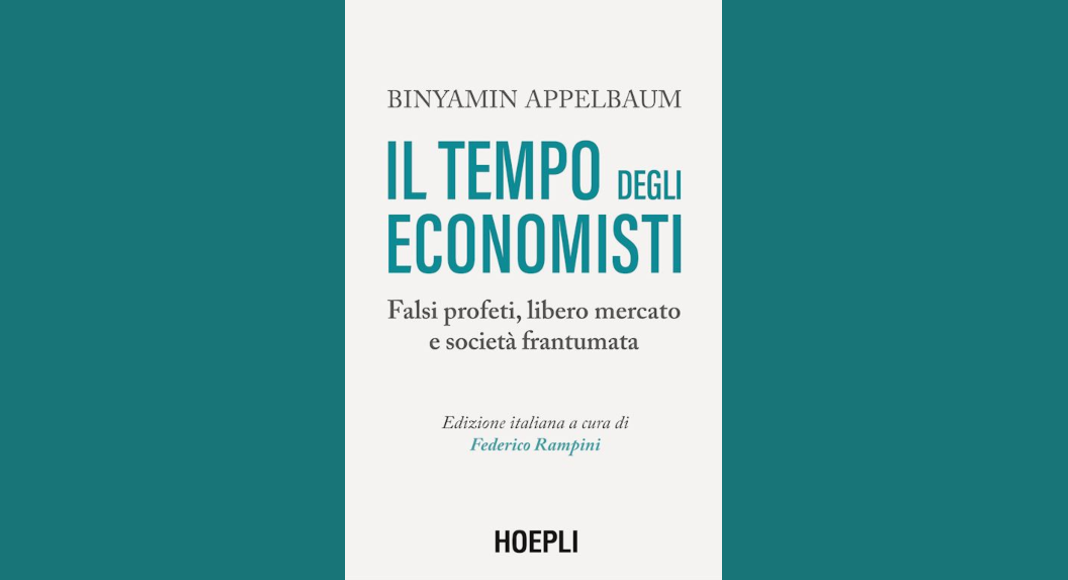Per ottimizzare i tempi delle discussioni con la moglie, l’economista Milton Friedman aveva ideato un modello che assegnava un numero a ogni frase ricorrente. In pratica, negli ultimi quarant’anni il mondo occidentale ha organizzato la propria linea economica, i propri programmi universitari e la propria politica monetaria sulle teorie di un tizio che, quando litigava con la moglie, le diceva «numero 2» al posto di «mi sbagliavo, avevi ragione tu».
Milton Friedman è stato il grande vincitore del secondo Novecento, il deus ex machina – per alcuni messianico, per altri diabolico – che ci ha lanciati tutti nella modernità; come un ciclista in fuga, sulla lunga distanza ha staccato con le sue teorie il grande rivale John Maynard Keynes e i suoi gregari, ponendo le basi non solo economiche ma anche valoriali del mondo in cui oggi viviamo. Ma Il tempo degli economisti. Falsi profeti, libero mercato e disgregazione della società (Hoepli, 2021) del giornalista Binyamin Appelbaum – editorialista della pagina economica del New York Times – non si limita a raccontare questa rivalità prendendo le parti dell’una o dell’altra fazione, bensì cerca di ricostruire una storia molto più decisiva per le sorti dell’Occidente: quella dell’avvento degli economisti come timonieri della politica, profeti che con le loro previsioni e i loro modelli hanno aperto la stagione dei comitati tecnici composti da esperti in grado non soltanto di influenzare l’operato dei governi, ma addirittura indirizzarlo.
Furono le teorie di Keynes, per esempio, a spronare Roosevelt ad adottare politiche espansive per uscire fuori dalla Grande Depressione, come furono gli articoli di Friedman a influenzare Nixon sull’opportunità, in termini di ottimizzazione tra costi e benefici, di abolire l’obbligo di leva reclutando professionisti che a una retorica difesa della patria anteponessero interessi ben più concreti, i soldi e la carriera, come in qualsiasi altra professione.
Friedman e Keynes non incarnavano soltanto due scuole diverse di pensiero economico, ma anche due visioni del mondo opposte, sebbene entrambe interne alle dinamiche del capitalismo. L’intento comune era salvare il capitalismo da quello che nel Novecento è stato lo spauracchio per eccellenza delle società occidentali: l’Unione Sovietica e il socialismo reale. Solo che per raggiungere questo scopo, i due imboccavano strade diametralmente opposte: Keynes vedeva nel capitalismo un sistema attraverso il quale poter raggiungere la piena occupazione, e per farlo cercò di mitigarne la spinta individualista con l’introduzione di politiche redistributive mutuate proprio da quel socialismo che voleva scongiurare; per Friedman invece lo stato doveva desistere da ogni interventismo e lasciare fare ai mercati, che lui considerava perfettamente capaci di autoregolarsi e più efficaci di qualsiasi governo nel garantire i diritti fondamentali dell’individuo. Da ebreo, Friedman era infatti convinto che solo il mercato potesse porre fine alle discriminazioni e alle persecuzioni di qualunque tipo, giacché per il mercato nessuna differenza conta davvero – non di sesso, non di etnia, non di religione, non di orientamento sessuale – se non una soltanto: il prezzo che ciascun individuo è disposto a pagare per ottenere un bene o servizio.
In sostanza la teologia friedmaniana si fondava su questa rivelazione, dalla quale poi scaturirono due comandamenti diventati dogmi per le generazioni future di economisti: l’economia come scienza predittiva e l’inflazione come principale nemico da combattere. L’idea che i modelli economici siano in grado di anticipare con esattezza scenari futuri e quindi governarne l’incertezza è una droga ancora molto spacciata tra gli studenti di economia che si preparano a diventare la nuova classe dirigente, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Si tratta a ben vedere di una mistificazione alla quale già aveva replicato il premio Nobel Herbert Simon – stranamente non citato mai da Appelbaum – con la sua teoria della razionalità limitata. Secondo Simon chiunque si affidasse con certezza scientifica alle previsioni economiche commetteva l’errore di non tener conto che gli uomini non sono macchine che agiscono secondo processi deterministici; i loro comportamenti sono altresì una variabile “irrazionale”, per cui, come in una partita di scacchi è impossibile prevedere tutte le mosse di un avversario, allo stesso modo l’economista non può in alcun modo ridurre l’intero quadro di possibilità a un modello certo, dovendosi affidare prima o poi all’intuito per uscire dall’impasse.
Ma se il primo comandamento della teologia friedmaniana riguardava una questione di atteggiamento epistemologico – atteggiamento miope che ci ha portato dritti alla crisi economica del 2008, che secondo i modelli friedmaniani non sarebbe mai potuta accadere – il secondo invece era una questione dannatamente pratica: l’inflazione. Per i keynesiani l’inflazione aveva un’origine multifattoriale, quindi ogni volta che aumentava in modo eccessivo, gli economisti avrebbero dovuto cercarne le cause nel contesto specifico nel quale era insorta. Friedman, invece, usava la falce: per lui l’inflazione era un’emanazione della politica monetaria, dunque occorreva limitare la produzione di moneta al fine di ridurre l’inflazione a percentuali minime. Se per trent’anni l’economia keynesiana aveva contribuito, nel bene e nel male, alla ricostruzione del dopoguerra fondando le socialdemocrazie capitaliste sulla libertà dei mercati, controbilanciata però da uno stato molto forte e politiche di welfare in grado di rimediare alle storture del sistema, il vento cominciò a cambiare quando si presentò uno scenario inedito.
Erano gli anni settanta e fino ad allora i keynesiani avevano operato in contesti in cui la disoccupazione era alta e l’inflazione bassa, pompando testosterone monetario per curare l’astenia occupazionale: lo stato immetteva denaro in circolo per riattivare i mercati e i consumi, lasciando che l’inflazione salisse anche di qualche punto per guadagnarne però in occupazione. Ma quando si verificò l’inedito scenario noto in letteratura come stagflazione, ossia la compresenza di un’alta disoccupazione e un’alta inflazione, l’opinione pubblica americana andò nel panico e il presidente Jimmy Carter fu costretto ad affidarsi alle cure friedmaniana, che nel frattempo non erano cambiate prescrivendo sempre la stessa medicina: controllare l’inflazione attraverso la riduzione della massa monetaria e farlo a ogni costo. Quel costo furono i milioni di posti di lavoro bruciati ogni anno in USA e UK dai governi Reagan e Thatcher, famiglie frantumate come cristalli, salari ritoccati al ribasso, tagli alle politiche sociali e redistributive che peggiorarono i servizi pubblici in favore del settore privato, mentre l’Europa dell’austerity prendeva appunti in vista di Maastricht.
Nonostante le ideologie friedmaniane siano diventate egemoniche costituendo attualmente un vero e proprio pensiero unico, i dati riportati da Appelbaum parlano chiaro: negli ultimi quarant’anni la disoccupazione nei paesi sviluppati è aumentata di più del doppio rispetto ai vent’anni precedenti, laddove il 75% della ricchezza è in mano ad appena il 10% delle persone. Come ammise con spietato candore Kieth Joseph, economista di riferimento di Margaret Thatcher, «se vogliamo aumentare il nostro tenore di vita, è necessario che le disuguaglianze aumentino». In quarant’anni i modelli liberisti, secondo i quali per eliminare la povertà i ricchi devono diventare sempre più ricchi, hanno mostrato tutto il loro potere di inganno, mentre il dogma dell’inflazione costantemente bassa ha portato vantaggio soprattutto a chi presta soldi, ossia banche e gruppi finanziari. Le previsioni a lungo termine di un benessere diffuso che, stando agli esperti, le ricette liberiste avrebbero dovuto realizzare, si sono schiantate come ciarlatanerie contro gli scogli della crisi economica del 2008 e l’attuale pandemia. Se oggi siamo arrivati al punto in cui i populismi autoritari avanzano, non è perché non abbiamo creduto agli economisti. Forse è per l’esatto contrario: ci siamo fidati troppo.
La storia tracciata da Appelbaum è la storia di un abbaglio politico collettivo, di cui lo scontro tra Keynes e Friedman è solo il punto di partenza. È una storia che passa per gli accordi di Bretton Woods e l’inferno liberista del Cile di Pinochet, per i merluzzi islandesi e i miracoli economici di Cina e Taiwan che ascoltarono le cattive profezie di Friedman, Hayek e gli altri liberisti ma poi fecero di testa propria. È un ritratto imparziale ma impietoso del pensiero economico dominante e più in generale della tecnostruttura, quel Moloch occidentale fatto di tecnici ed esperti disciplinari il cui lavoro dovrebbe garantire alla collettività maggiore sicurezza e ridurre l’incertezza generale, ma che nel corso degli ultimi decenni ha finito per produrre effetti diametralmente opposti. Il lavoro intellettuale degli esperti, e in particolare degli economisti, è utile finché i suoi benefici vengono ridistribuiti dal centro alle periferie, dall’alto in basso della scala sociale, ma quando questo non avviene più, la fiducia collettiva nell’operato dei tecnici crolla poiché la tecnostruttura, nonostante influenzi in modo sempre più stringente le nostra vite, diventa anche progressivamente più distante dagli interessi comuni.
Per usare lo stesso lessico dei protagonisti di questa storia, Il tempo degli economisti è un tempo dai rendimenti decrescenti, in cui gli esperti si chiudono a riccio sulle loro procedure normative inderogabili e pretenziosamente esatte, spacciando tendenze ideologiche per scienza neutra ed esatta: Friedman cianciava di libertà, ma poi insieme ai suoi discepoli chicagoani andava in Sudamerica a dettare l’agenda economica a un sanguinario dittatore.
Dal racconto di Appelbaum si evince che a tutti questi illustri geni dell’economia interessasse una cosa sopra ogni altra: la lotta per il prestigio, ovvero l’accumulazione di un capitale simbolico a garanzia di uno status superiore che si svolge sui ring delle aule universitarie, dei paper accademici, dei consigli di amministrazione, dei centri finanziari, aprendo un conflitto tra chi gestisce la conoscenza, e quindi un potere, e chi quel potere lo subisce. Il problema riguarda l’intera categoria dei competenti, verso i quali sempre più spesso è indirizzato il malcontento delle masse ben capitalizzato da sciacalli senza scrupoli, ma è un problema che ha i suoi fondamenti nell’economia liberista, cattiva consigliera della politica bipartisan degli ultimi quarant’anni: «Non è una novità che le crisi finanziare corrodano la fiducia nella democrazia liberale. Uno studio delle crisi finanziarie nelle nazioni sviluppate dal 1870 ha evidenziato che, spesso, i partiti politici di estrema destra ne traggono vantaggio, perché conquistano il sostegno popolare, incolpando immigrati e minoranze della perdita di prosperità”.
Che il libero mercato garantisca di per sé maggior livelli di democrazia, si sta rivelando l’ennesimo mito – il mito fondante – dei profeti della scienza cattiva.