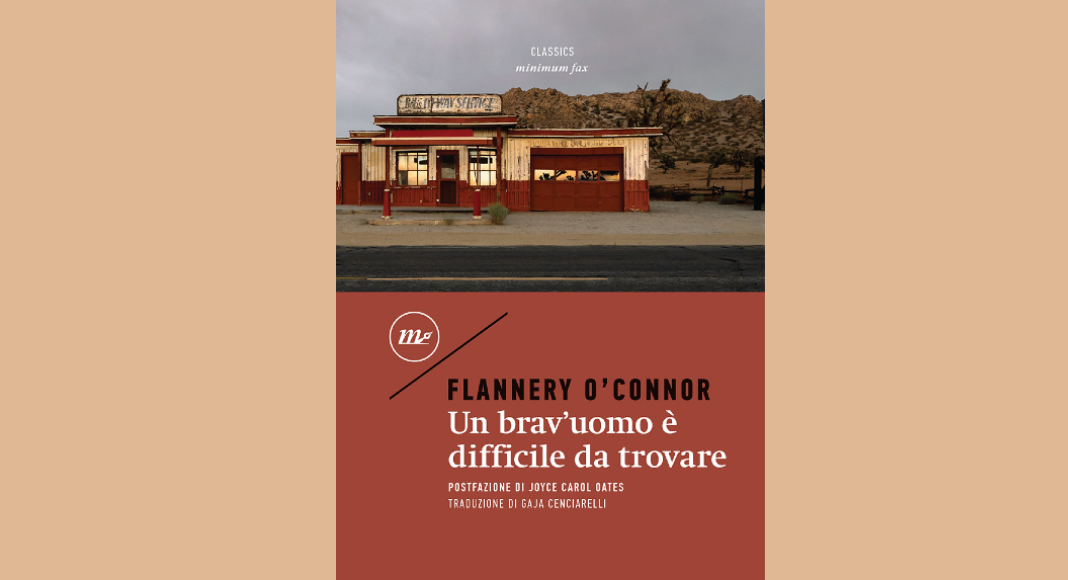Il 1952 è l’anno di svolta nella vita personale e professionale di Flannery O’Connor: pubblica il suo primo romanzo e riceve la conferma che la malattia che la sta tormentando è il lupus che le ha ucciso il padre solo pochi anni prima. Ad entrambi reagisce con la forza e la determinazione che le sono proprie: considera infondate ed immotivate le feroci critiche che riducono gli sforzi di sette anni ad un’opera prima di sicuro valore sul piano artistico, ma peraltro oscura ed inquietante. E relega la malattia ad un mero accidente esterno, ininfluente: «le energie per scrivere non mi mancano e siccome se c’è una cosa che devo fare è appunto quella, riesco, con un occhio guercio, a prenderla come una benedizione». In ogni caso, affronta e dimentica le difficoltà sedendo alla scrivania, dichiarando con sottile autoironia che per scrivere non le servono le gambe, ma la testa.
Convinta di avere solo tre anni di vita, come è stato il sofferto decorso paterno della malattia, tra il 1952 e il 1955 la O’Connor dedica ogni energia alla scrittura, che considera la sua vocazione. Pubblica su riviste di prestigio alcuni tra i suoi migliori racconti, e tra questi ne sceglie dieci per la prima raccolta Un brav’uomo è difficile da trovare, la stessa appena riproposta nella traduzione di G. Cenciarelli da Minimumfax. Poco prima della pubblicazione prevista per giugno del 1955, la O’Connor riceve l’invito a prendere parte al programma televisivo GalleyProof negli studi di New York, trasmissione che fa da trampolino di lancio per le opere più interessanti di giovani scrittori. Nonostante si dichiari a disagio con i giornalisti, accetta e confida ad un’amica:
«Tutti quelli che hanno letto La saggezza nel sangue pensano che sia una zoticona nichilista, mentre mi piacerebbe dare l’impressione alla televisione di essere una zoticona tomista. Molto probabilmente non riuscirò a pensare a nulla da dire a Harvey Breit se non ‘Ah?’ e ‘Non so’. Quando tornerò dovrò trascorrere tre mesi giorno e notte nel pollaio per neutralizzare le influenze malefiche».
Effettivamente l’intervista si svolge come temuto. Harvey Breit, esperto giornalista, riesce a rendere l’incontro interessante e a far emergere le convinzioni e le opinioni della scrittrice nonostante questa sia poco loquace e risponda con incisi sibillini. Due risposte, decise e chiare, mostrano già la chiarezza dei suoi intenti e rivelano gli assunti fondamentali della sua narrativa, in altre parole delineano i “mystery and manners” che i curatori sceglieranno come titolo per la raccolta dei suoi saggi sull’arte dello scrivere. Alla domanda su cosa lei, in quanto autrice, intenda per scrivere, risponde senza esitare:
«Penso che uno scrittore serio descriva un’azione solo con il fine di rivelare un mistero. Ovviamente, potrebbe anche essere sul punto di rivelare il mistero a se stesso nello stesso momento in cui lo sta rivelando agli altri. Potrebbe addirittura non riuscire a rivelarlo a se stesso, ma credo che debba almeno percepirne la presenza».
Per lei, profondamente cattolica, la narrativa rimarrà sempre lo strumento con il quale mostrare come l’uomo si pone nei confronti del mistero della vita creata: «se c’è una cosa tremenda a scrivere quando si è cristiani è che per te la realtà suprema è l’Incarnazione, la realtà presente è l’Incarnazione e all’Incarnazione non ci crede nessuno».
È questa una convinzione che ha maturato negli anni universitari lontano da casa e che l’ambiente del suo Sud in veloce trasformazione le sta confermando: nell’epoca contemporanea gli uomini stanno perdendo la sensibilità ai valori spirituali dell’esistenza. L’uomo moderno considera la religione la risposta ad un bisogno personale, una confortevole «coperta elettrica» e non è più in grado di individuare il diavolo in quanto tale, una presenza reale che affascina e seduce. Perciò ogni storia è costruita con certosina abilità per condurre il protagonista a compiere quel gesto «particolare, diverso da tutti gli altri», il gesto che pone il personaggio nel punto in cui «spazio, tempo ed eternità si incontrano». È questo il momento in cui il protagonista incontra la violenza della grazia divina che stravolge i cardini della sua esistenza e schiude alla la consapevolezza della presenza della salvezza. E ciò che le storie della O’Connor mostrano è proprio «l’azione che la Grazia esercita su un personaggio poco disposto ad assecondarla» per strapparlo da un territorio in «gran parte tenuto dal diavolo» e reindirizzarlo.
Il paradosso di ciascuna delle sue storie è proprio nell’apparente inconsulta violenza che cela la promessa della salvezza e ogni racconto di questa raccolta è la rappresentazione narrativa di questa dinamica. Il significato profondo dell’annegamento del piccolo Harry/Bevel è l’aver raggiunto l’unico luogo in cui «conta davvero» sfuggendo così alla nefasta influenza di genitori distratti ed anafettivi. Solo con l’incendio della sua fattoria la signora Cope comprende che il bene per cui sta lottando non è l’efficienza della sua proprietà. Così il furto della gamba di legno costringe Hulga/Joy a riconsiderare le proprie nichilistiche convinzioni, e l’aver rinnegato il proprio nipote obbliga il signor Head a riconoscere che ciò che voleva insegnargli con il viaggio in città è inconsistente nella prospettiva di Dio.
La scrittrice respinge, però, con disdegno l’idea che un racconto possa avere altri fini se non «far vedere come si comporta davvero certa gente, come si comporta a dispetto di tutto», quindi per essere convincenti, perché la storia funzioni, cioè agisca tanto sul piano orizzontale della narrazione quanto su quello verticale del significato, «bisogna creare un mondo dotato di peso e spessore». E lei ci riesce dipingendo con le parole il suo Sud che riportano sulla pagina la parlata, i modi, le convinzioni, i pregiudizi delle persone che vivono accanto a lei: signore bianche benpensanti, avide, furbe; braccianti bianchi indolenti, scaltri; figli insofferenti e ribelli; neri rispettosi delle convenzioni sociali. La O’Connor, però, scortica questa realtà cui sente di appartenere, così i suoi personaggi, visti nella prospettiva che comprende l’infinito di Dio e che lei definisce “realismo cristiano” appaiono grotteschi, deformi nell’animo o anche nel fisico. A volte talmente brutali e orrendi che la madre Regina l’accusa di sprecare il suo talento in storie assurde e personaggi disgustosi mentre potrebbe utilizzarlo molto meglio scrivendo storie che piacciano, di personaggi “carini”. Se alla mamma risponde con il rispettoso silenzio di chi sa di essere nel giusto, alla signora che si lamenta che queste storie le hanno lasciato l’amaro in bocca, replica piccata «Non era previsto che se le mangiasse!». Ai critici che valutano i racconti assurdi, volutamente ed inutilmente violenti, ritagliati oltre il solco della tradizione del grottesco del Sud, la O’Connor fa notare che stanno prestando attenzione all’orrore sbagliato, perché l’orrore vero non è quello di una famiglia sterminata da un evaso, di una ragazza mentalmente debole che viene abbandonata, di tre ragazzi che danno fuoco ad un bosco, di un adolescente che non si accorge della morte del prozio perché è in fila per una Coca-Cola, ma quello dell’essere umano che non è più in grado di riconoscere la presenza di Dio.
Il programma televisivo prevede che l’intervista venga interpuntata da tre attori che interpretano il racconto «La vita che salvi può essere la tua», qualche anno dopo dallo stesso verrà tratto un film con Gene Kelly nelle vesti di Tom Shiflet, il protagonista con un braccio solo che in cambio dell’auto che ha rimesso in funzione accetta di sposare, e subito dopo l’abbandona in un diner, la figlia mentalmente disabile della proprietaria. Nella versione cinematografica, invece, Tom si pente e torna dalla ragazza: la O’Connor è profondamente delusa dalla revisione della storia che ne snatura il significato originale, ma soprattutto dalla reazione degli spettatori che apprezzano molto di più l’edulcorata versione televisiva. Come aveva già schiettamente dichiarato a Harvey Breit, che durante una pausa degli attori le aveva chiesto di riassumere la storia, lei rimane convinta che : «No, assolutamente no. Non penso si possa parafrasare una storia come quella. Penso ci sia solo un modo per raccontarla ed è quello con cui la storia è stata raccontata».
Le ore che per disciplina e convinzione si impone quotidianamente alla scrivania servono a questo: non basta avere una storia per raccontarla, bisogna saperla mettere sulla pagina. E lei scrive, riscrive, invia copia dei suoi dattiloscritti agli amici, corregge alla luce dei commenti e delle critiche, e rielabora. Il risultato sono racconti in cui nessuna riga è sprecata e ogni parola ha la sua precisa e necessaria collocazione. Il livello di profondità al quale un lettore può arrivare dipende, per la O’Connor, esclusivamente dalla predisposizione del fruitore a mettersi in gioco, ma questo non è più un problema della scrittrice. Il problema vero di ogni scrittore sta nel costruire storie che consentano di «offrire intrattenimento sull’immediato piano fisico a un certo tipo di lettore» e, al tempo stesso, «offrire maggior profondità di significato al lettore provvisto degli strumenti per coglierla».
Questi dieci racconti della prima raccolta alla O’Connor piacciono «più che a chiunque altro» tanto che confessa: «li leggo e li rileggo e mi sbellico dalle risate, poi mi ricordo che li ho scritti io e un po’ mi vergogno». Ottengono all’epoca un buon successo di pubblico, tanto è vero che Catharine Carver, il suo editor, le scrive facendole presente che il libro è tra le opere più di successo che hanno in catalogo, secondo solo a Thomas Merton, e Flannery ironizza che «ciò, in realtà, non depone molto a favore del loro catalogo». A Milledgeville, la sua cittadina, diventa una celebrità, ma lei reagisce con la solita contrarietà, convinta che «tutti mi stringono la mano, ma nessuno legge le mie storie». Parole smentite allora come oggi.