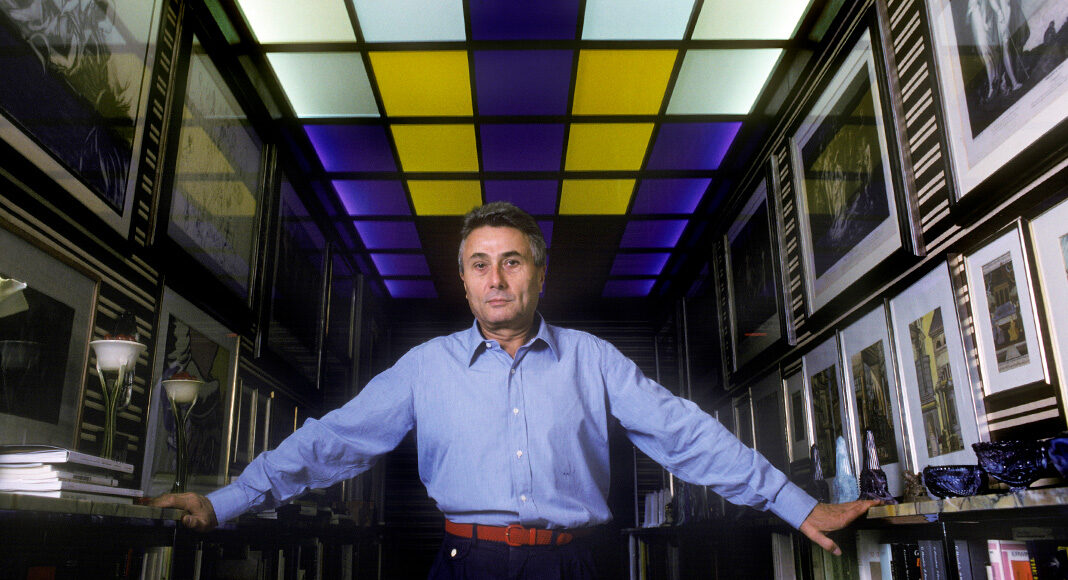Il 22 marzo 2020 è morto a Roma Alberto Arbasino e con lui è finito il Novecento. Nato a Voghera nel 1930, Alberto Arbasino, autore di racconti e romanzi come Le piccole vacanze (Einaudi, 1957) e Fratelli d’Italia (Feltrinelli, 1963), di saggi di critica letteraria come Certi romanzi (Feltrinelli, 1964) e Sessanta posizioni (Feltrinelli, 1971), di saggi politici e d’intervento civile come In questo Stato (Garzanti, 1978) e Un paese senza (Garzanti, 1980), tanto per citare alcuni titoli dalla sua ricchissima produzione, è stato l’ultimo rappresentante di un modo di vivere e pensare la letteratura che, negli ultimi vent’anni, si è inabissato progressivamente sotto il letto della storia. Si chiude così un secolo iniziato il 20 febbraio 1909 con la pubblicazione del manifesto Futurista di Marinetti su “Le Figaro”, e che si chiude ben oltre i limiti cronologici del nuovo secolo e del nuovo millennio. Il Novecento è un secolo contraddittorio, problematico, ricco di tradizioni, (molto più ricco di quello che ci raccontano storiografie e antologie vecchie e obsolete), che oggi possiamo guardare con una lucidità diversa, come il camminatore che si volta indietro e guarda il paesaggio della pianura dall’alto di una collina. Questo è uno dei privilegi di vivere in questo tempo, l’altro sono le conseguenze che questo sguardo comporta: ripensare il canone letterario, riscrivere antologie, rinegoziare temi e valori culturali al di là delle mode.
Le date, in questo caso, non sono arbitrarie. Con la morte di Arbasino si spegne la tensione, la forza motrice, la corrente elettrica che ha attraversato tutto il Novecento e che oggi non c’è più. La rivoluzione futurista fa divampare un fuoco incendiario che attraversa tutto il Novecento chiedendo con urgenza, (in un paese sostanzialmente contadino e analfabeta, ma con i segni di una prima industrializzazione centrata soprattutto a Milano), un nuovo modo di raccontare la realtà, una nuova parola in grado di sintetizzare le molteplici sensazioni che vive un uomo nelle città moderne, con una sintassi adeguata, non più logico-grammaticale ma segnica, con pagine graficamente esplose, da leggere come uno spartito musicale ad alta voce, capace di cogliere la simultaneità delle sensazioni e delle percezioni, con nuovi ritmi sincopati, con nuove tecnologie, per definire la velocità del muoversi, del pensare, del vivere. Una vera e propria corrente elettrica che passa dalle avanguardie dei primi anni venti, (Cesare Zavattini sarà capace di far esplodere un Non libro Bompiani nel 1970), coinvolge la tradizione dei giornali satirici e umoristici, per arrivare al Gruppo 63, che rivendica una continuazione con il futurismo (Gruppo 63 Il romanzo sperimentale, Palermo 1965, Feltrinelli, 1966) e coinvolge scrittori come Manganelli, Celati e Tondelli, per passare infine verso più innocui nipoti e nipotini vari degli anni Novanta. Una corrente d’inquietudine e di voglia di rivoluzione, di adeguare la lingua e la sintassi su altri ritmi, che attraversa tutto il Novecento e che si è spenta e inabissata con la morte del Nino Alberto (per gli amici).
Per capire l’oggi e il Novecento bisogna dunque rileggere Arbasino, partendo da questa dialettica profonda che attraversa tutto il secolo, tra ordine e disordine, tra avanguardie e tradizione, tra la distruzione e ricomposizione della sintassi e la ricerca di una prosa classica ed elegante capace di resistere al tempo (vedi la prosa d’arte). Una dialettica che scorre sotto i vari -ismi, al di sotto di scuole o correnti letterarie con le quali siamo abituati a incasellare e a studiare il Novecento, obbligando lo studioso, lo studente, l’insegnante e il lettore ad una visione approssimativa, distorta e spesso miope. Si studiano gli autori come monadi, si studiano i movimenti e le correnti a compartimenti stagni, impendendo la visione d’insieme di un continuum temporale che si è spento il 22 marzo 2020 della morte di Arbasino.
Arbasino ha scritto uno dei capolavori dei primi anni venti del secolo, Ritratti italiani, Adelphi, 2014, in cui biografia, saggio critico, racconto, aneddoto, testimonianza, ricordo si fondono insieme in brevi ritratti da far leggere e studiare ai narratori e ai giornalisti italiani per capacità di sintesi, intelligenza e umoralità. Arbasino insegna che la letteratura è anche un modo per fare i conti con il passato. Uno dei pezzi memorabili è il ritratto dedicato ad Alberto Moravia, che liquida in dieci righe dopo un acutissimo saggio di due pagine sulla sua scrittura, peggiore di quella del “New York Times”:
Da ragazzo, Moravia era seccante e antipatico. Raccontava un famoso clinico che quando loro giovanotti andavano a prendere le due sorelle maggiori per qualche thé dansant, e la mamma De Marsanich li accoglieva amabilmente, il giovane autore degli Indifferenti, si divertiva a tagliare e cucire le loro maniche e tasche in anticamera. Nella sua età di mezzo, era dispettoso e prepotente. Quanti dissapori. Me ne ha fatte di tutti i colori. Finalmente, in vecchiaia, magro e non più tozzo, diventò giocondo e piacevole. Non ripeteva più “uffa uffa”, piuttosto diceva «semo tutti peracottari». Anche perché in trattoria si chiedevano le pere cotte. Per vezzo, portava giacche chiare e foularini al collo. Gliene regalai sette, naturalmente di Charvet, per i suoi settant’anni. Commentò “A Roma si chiamano strangolini”. Purtroppo non sono andato a un ultimo suo pranzo, da Elisa Olivetti (Bucci Casari e quindi napoleonide), che avendo sposato un Maraini fratello del padre considerava Dacia come nipote, e Alberto scherzando anche. Stava bene. Morì in bagno. Ci mancherà moltissimo.
La triplice frase finale sa di lapidario e definitivo: “Stava bene. Morì in bagno. Ci mancherà tantissimo”. L’ironico superlativo diventa il suo ferocissimo contrario.
Spesso mi dicono che Arbasino è difficile da leggere, specialmente per le nuove generazioni, è complicato, che i suoi riferimenti culturali non si addicono al lettore medio. Fa riflettere una sua riflessione, sempre nel testo di Moravia, in cui parla dell’editoria:
“perché proprio solo nel nostro ‘ramo’ si dovrebbe venire incontro alle richieste dei consumatori che pretendono prodotti «alla portata di tutti», cioè al livello più basso del commercio, mentre nel mangiare e nei vestiti e magari nelle altre arti esigono qualità ‘exclusive’ e ‘vip’ e ‘top’?”
A pranzo e cena pretendiamo piatti da grande cucina e poi ci accontentiamo del peggior fast food editoriale e narrativo. Arbasino pretende un lettore alla sua altezza, uno che sa cogliere nella sua pagina la ricchezza stilistica, la bellezza della prosa da leggere sempre ad alta voce, come un testo teatrale o uno spartito musicale. Arbasino è capace di orchestrare parole e suoni esotici, con accostamenti sonori in cui l’umorismo esplode come un fuoco d’artificio linguistico, senza dir in concreto nulla: una vera parodia linguistica. Basta rileggersi questo brevissimo appunto nei suoi Pensieri selvaggi a Buenos Aires, (Adelphi, 2012). Alla trama del racconto è sostituita la tecnica di un puro, sonoro, accumulo pirotecnico di parole, un elenco in crescendo che sarebbe piaciuto tantissimo a Umberto Eco. Il ritmo diventa il protagonista, Arbasino suona le parole come maracas al ritmo di una samba:
Saludos amigos, adiós muchachos, vamos a la playa, compañeros, descamisados, descalzas, desnudas, barbudos, guapas, gringos, ninos, ninas, Mercedes, Dolores, Milagros, Borges, Paraguayos, zarzuela, Consuelo, Piazzolla, Pilar, Gardel, Trinidad, Soledad, Asunzión, Concetipión, Corazón, revolución, reacción, rebelión, represión, extenuasión, esteriosización, bodegón, salchichón, maricón, cospetón siór parón…tan solo una canción
…Hombre! Sangre! Dinero! Sombrero! Limon Limonero! Bombero! Me muero! Te quiero! Todos caballeros! Toreador! Mirador! Findador! Parados! Guantanamera! Violetera! Santander! Mercader! Escobar! Bolivar! Alvear! Miramar! Minibar!
Oggi, dopo Arbasino, non c’è nessun scrittore (e spero di sbagliarmi) che rivendichi le sue radici in un Novecento così ricco e lontano, in una posizione di rivoluzione linguistica che si rifà a quel mondo, a quella tradizione, a un modo di scrivere capace di scardinare la prosa verso la ricerca di una nuova grammatica e sintassi capace di adeguarsi al mondo che stiamo vivendo. Il Novecento è diventato muto. Anche in molte pagine di autori nuovi, anche giovani, non c’è nessuna eco di un Novecento che non conoscono, (che probabilmente non hanno mai studiato o non gli han fatto studiare), e se lo conoscono non parla loro. Viviamo in un altro tempo, in un altro mondo. Eppure la pagina di Arbasino è viva e forte ancora oggi, è potente, ricca, divertente e divertita. Lo considero uno dei grandi umoristi vissuto a cavallo di due secoli. I suoi Rap! (Feltrinelli, 2001) e Rap 2 (Feltrinelli, 2002) scritti a 61 anni (meglio di quelli di Sanguineti) sono la dimostrazione di come si possono usare forme poetiche alla moda, con intelligenza, scardinandole così far fare una figura barbina ai rapper arrabbiati che sembrano suoi nipotini di quarto grado.
Così, l’unico vero modo per onorare degnamente questo scrittore civile, engagé, è quello di leggerlo e rileggerlo, perché è divertente, feroce, intelligente, con una forza etica impressionante, e soprattutto indica utili strade narrative a chi scrive. Ricordandoci inoltre che le recensioni sono cose serie. Il ritratto di Christopher Isherwood in Ritratti e immagini, Adelphi, 2016, che completa il primo volume dei Ritratti italiani, è un invito che fa pensare e getta una luce di morte su tanti libri e tanta fiction di oggi.
Christopher Isherwood
Su diversi libri di memorie moderne una recensione non può essere interamente una routine, perché quasi in ogni generazione scattano certi meccanismi del ricordo. E fanno comprendere ai non più bambini come mai, anche in parecchi importanti secoli del passato, il gusto di leggere e scrivere soprattutto di «cose viste» autentiche prevalga – con l’età –- sopra invenzioncine di una “fiction debole”, poco interessante perché riferisce i non eventi e i pensierini da Caro Diario di autori che non hanno avuto vita, e inoltre non vivono (né per dono creativo, né per grazia stilistica) sulla paginetta.
Insomma, «Palazzeschi andò a trovare Marinetti», o «Edmund Wilson ribatté a Nabokov», o anche «Montgomery Clift salì in macchina per raggiungere Elizabeth Taylor», sono spesso più attraenti che «Mi svegliai di soprassalto», o il «Il babbo appariva invecchiato», o «Elsa e Natalia tacquero a lungo», o «Bob cucinò una bistecca». Ma del resto anche le Vite del Vasari e le Memorie di Saint Simon si leggono più volentieri che un poema o una tragedia, perché le traversie del Rosso Fiorentino o di Elisabetta Farnese van sempre meglio di una Cleofe che rattristossi e di un Poro che procombe.
Qualunque imputato di un processo minore in pretura sarà più avvincente del miglior protagonista di sceneggiati su un intellettuale impegnato in crisi di coppia con la Rai, e tanta rabbia dentro per le belle estati romane di una volta, ma tanto sentimento quando torna al paese e rivive l’infanzia rustica con la zia.
Ecco perché Arbasino è tanto attuale. Il Novecento è morto ma Nino Alberto è vivo, vivissimo.