Palermo non gli piaceva, e anche per questo imparò ad amarla. Perché Paolo Borsellino apparteneva a quella umanità che dimostra i sentimenti nella concretezza dei gesti, senza tanti annunci programmatici o di interesse: “Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare”.
E Borsellino ci ha provato con tutti i suoi mezzi, fino al 19 luglio del 1992, a cambiare Palermo e a sconfiggere la mafia, senza perdere il sorriso né la gentilezza. Da Monreale a Palermo, da Marsala all’Asinara. Da giudice istruttore a procuratore della Repubblica, ma anche da padre, marito, amico: sempre a disposizione di un prossimo che aveva necessità di essere ascoltato e senza far sentire il suo grado di magistrato.
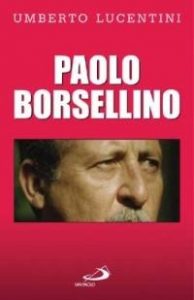
A quasi trent’anni dalla strage di via D’Amelio, Umberto Lucentini, giornalista e autore della biografia Paolo Borsellino (San Paolo Edizioni, 2022), tratteggia nuovamente il suo ritratto e contribuisce a custodirne l’integrità della sua figura negli anni.
Qual è stato il suo primo incontro con Paolo Borsellino?
L’ho conosciuto subito dopo il suo arrivo a Marsala. Lavoravo al Giornale di Sicilia e collaboravo con il settimanale Europeo, occupandomi già di cronaca giudiziaria. Dovevo scrivere per il settimanale un articolo su una procura di periferia, quale Marsala, e di un magistrato che aveva appena terminato l’istruttoria del maxi processo. Mi incuriosiva capire cosa avrebbe fatto un magistrato di quel calibro in un contesto periferico.
Il periodo di Marsala delinea una delle caratteristiche principali di Borsellino: la capacità di anticipare i tempi, intuire quanto la mafia di provincia incidesse su quella palermitana.
Borsellino quel giorno mi spiegò che indagando sul maxi processo, quindi sulle cosche di Cosa nostra, sull’ascesa dei corleonesi di Totò Riina e Bernando Provenzano, aveva scoperto che questi capomafia avevano un legame fortissimo con la provincia di Trapani e più in generale con le zone di Mazara del Vallo e Castelvetrano, che ricadevano sotto la competenza territoriale della procura di Marsala. Borsellino è stato il primo a capire che i legami di Cosa nostra palermitana con quella provincia erano fortissimi. Si è scoperto solo dopo il 1992 e le stragi che Totò Riina era solito passare parte della sua latitanza a Mazara del Vallo. Inoltre Borsellino, con l’aiuto degli investigatori, ha capito il ruolo della famiglia Messina Denaro, da cui proviene Matteo, il più pericoloso latitante italiano ricercato dal 1993.
La nomina di procuratore a Marsala fu anche oggetto di critiche da parte di Leonardo Sciascia nell’ articolo I professionisti dell’antimafia. Quali furono le reazioni di Borsellino?
Sciascia scrisse un articolo per Il Corriere della sera in cui di fatto Borsellino veniva dipinto come un professionista dell’antimafia, perché il Consiglio Superiore della Magistratura in quella occasione aveva preferito destinare all’incarico di procuratore di Marsala un magistrato che aveva un’anzianità inferiore rispetto all’altro concorrente, e di fatto compiendo una scelta di campo, preferendo chi aveva una professionalità in temi di lotta contro Cosa nostra, rispetto a un altro magistrato. Essere additato come professionista dell’antimafia è stato davvero troppo. Borsellino ha capito subito che probabilmente Sciascia era stato indotto in errore nello scrivere quell’articolo e nell’esprimere quelle valutazioni su di lui, tant’è che anni dopo in un successivo incontro con Sciascia, proprio a Marsala, i due ebbero un incontro di “pacificazione”. L’articolo di Sciascia è stato importante e al tempo stesso nefasto perché ha dato fiato alla parte di società che osteggiava il lavoro dei magistrati antimafia in Sicilia. La polemica fu un tentativo, utilizzato da molti, per indebolirli.
L’organizzazione del pool è l’intuizione decisiva per la lotta contro la mafia. Quanto è stata determinante la complicità tra i quattro giudici, con il nuovo metodo investigativo?
Il pool è una vera “rivoluzione culturale” ancora oggi, vista a tanti anni di distanza. Il metodo investigativo, inventato da Rocco Chinnici e proseguito con Antonino Caponnetto, mette a disposizione di tutti i magistrati le informazioni. Certamente la complicità è stata fondamentale: Falcone e Borsellino si conoscevano fin da bambini, frequentavano la stessa parrocchia ed essersi ritrovati da adulti, da magistrati a Palermo, con le stesse fondamenta e principi, ha rappresentato l’arma vincente. Scherzavano e parlavano lo stesso linguaggio, ed essendo cresciuti in un quartiere popolare, conoscevano sia “gli sbirri” che il modo di pensare dei mafiosi. Avevano la stessa “palermitudine”, Falcone e Borsellino: sapevano cogliere i segnali, decifrare gli sguardi di chi era stato mafioso e che si fidava di loro come magistrati, decidendo di diventare collaboratore di giustizia. La loro complicità e la loro origine comune sono state messe al servizio del pool antimafia.
E il linguaggio di Borsellino è stata la sua arma vincente?
Borsellino ha sempre avuto la capacità di mettersi alla pari con gli altri. Questo era il suo segreto. Durante il nostro primo incontro, da giornalista di 24 anni, alle primissime armi, quel giorno mi sono sentito… Enzo Biagi: quel pomeriggio mi ha dedicato almeno un’ora del suo tempo, raccontandomi dal maxi processo all’ incarico a Marsala, dandomi attenzione, facendomi sentire come un giornalista importante, anche se ovviamente non lo ero.
Falcone e Borsellino. Due mondi distanti per politica, idea di famiglia, carattere e senso dell’umorismo. È stata una totale complementarietà?
Il carattere dei due era molto diverso. Falcone appariva molto più chiuso eppure, come racconta Manfredi, Borsellino del periodo trascorso all’Asinara, rideva e scherzava e si divertiva a pescare, sembrava un altro uomo in quei giorni: non aveva il condizionamento di essere sempre all’erta, di temere che ogni cosa che avrebbe detto o fatto poteva essere interpretata a suo sfavore e finire nel tritacarne mediatico. Poi il fatto che Falcone non avesse figli e Borsellino sì, era una differenza enorme, ma per la paura di dover svolgere il proprio lavoro quotidianamente e pensare a un’eventuale ritorsione sulla famiglia. Che poi avessero avuto da giovani idee politiche distanti, non penso che sia mai stato motivo di ostacoli nelle loro relazioni.
Nel suo libro biografico, sottolinea una sequenza di numeri ricorrenti nella vita del giudice: la morte a 52 anni, come il padre e lo zio, le stanze in successione di Borsellino e Falcone, 63 e 64. C’è quasi una cabala che giustifica il fatalismo di Borsellino, questo come si concilia con il suo cattolicesimo?
I figli di Borsellino – Lucia, Manfredi e Fiammetta – e la moglie, Agnese, con i quali di fatto ho scritto questo libro, raccontano che Borsellino scherzava spesso con il tema della morte, per esorcizzarla. Fiammetta prima dell’estate del ’92 gli comunica che vuole andare in Africa con alcuni suoi amici, e il padre le risponde: “Se tu sei in Africa in un villaggio sperduto, come faccio a telefonarti per dirti che mi hanno ammazzato?”. Questa è una frase drammatica detta alla figlia con il sorriso sulle labbra, ma che rende evidente quale fosse l’atteggiamento di Borsellino nei confronti del fatalismo, che non è mai stata rassegnazione. Negli ultimi giorni della sua vita ripeteva: “Devo fare in fretta”, ma non solo per convinzione della morte ormai prossima, ma perché voleva ottenere risultati investigativi nel più breve tempo possibile.
La biografia, in origine, doveva essere un po’ diversa: un libro scritto a quattro mani con Borsellino.
Nel periodo da procuratore a Marsala, Borsellino stava cominciando un’inchiesta importantissima che partiva da Partanna, grazie alla testimonianza di Piera Aiello e Rita Atria (testimoni di giustizia raccontate in un altro libro di Umberto Lucentini, Maledetta Mafia, ndr). in quanto appartenenti, loro malgrado, ad una famiglia mafiosa. Borsellino ha potuto fare luce su un territorio fino ad allora blindato, dove i segreti di mafia non trapelavano. Gli proposi di scrivere un libro sulle donne e la mafia, un tema che allora, nel ’91, non era così frequente, ma un fenomeno che stava rivelando tutta la sua importanza. Borsellino era d’accordo, però suggerì di ampliare il libro con la sua vita da giudice, successi e delusioni, gli amici che lo avevano tradito e i nuovi che aveva incontrato a Marsala. Il progetto era iniziato così, poi Borsellino fu trasferito a Palermo e non abbiamo fatto in tempo a finire il libro. Dopo il 19 luglio, è stata la famiglia Borsellino a dirmi: “Questo progetto deve andare avanti. Paolo Borsellino deve continuare a vivere anche grazie alle parole di un libro”. E abbiamo cominciato questa bellissima avventura.

















