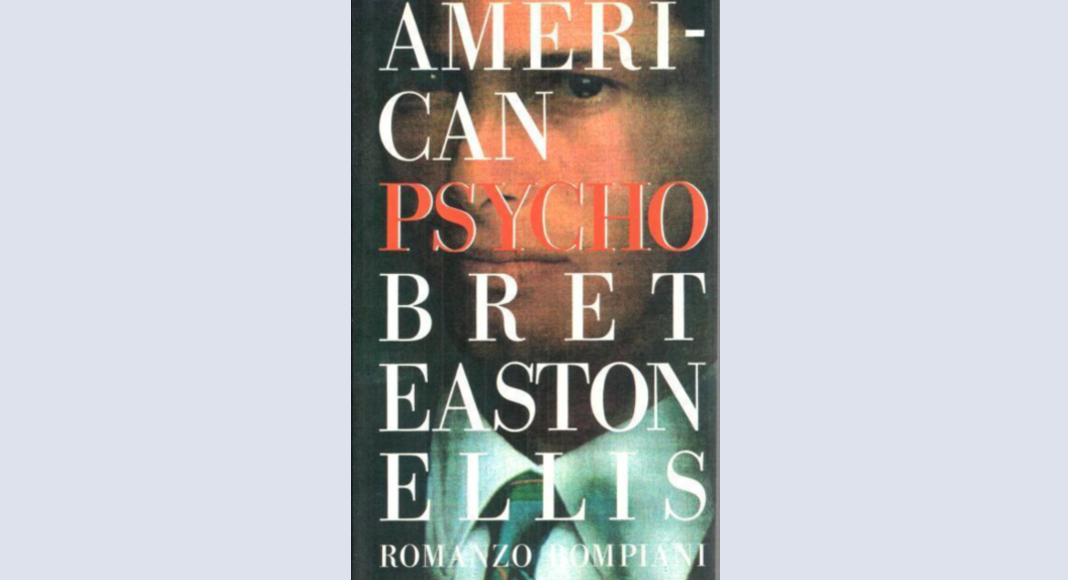Perché un romanzo si attira odio e insulti, esaltazioni e condanne, lunghe analisi e fulminee stroncature? Il periodo è quello coincidente con lo pseudo splendore anni Ottanta, le due presidenze Reagan, la conseguente Reaganomics, gli squali di Wall Street (i due nomi di Michael Milken con i suoi junk bonds – titoli spazzatura e Donald Trump palazzinaro sono ampiamente rappresentativi), la lotta alle democrazie popolari e filomarxiste del Centro e Sud America, l’Iran/Contras connection, Hollywood che fa trionfare le commediole sceme e iper-speranzose.
L’ottimismo, ritornello basilare di quegli anni, viene posto come obiettivo del tiro a segno socio-letterario di Bret Easton Ellis. Lo slogan «Make America great again» reiterato da Trump in realtà è di Reagan. Ed Ellis dell’ottimismo ne fa strage; come nel romanzo fa fare a pezzi al suo protagonista un buon numero di persone, soprattutto ragazze, molto belle, stupidine, benestanti o ricche, magari innamorate di lui. Del resto il protagonista è un ragazzotto sui ventidue, dirigente di una classica società finanziaria a Wall Street. Potrebbe perfettamente fare suo l’identikit che traccia di sé stesso un suo collega:
«Sono giovane, senza scrupoli, altamente motivato, altamente qualificato. (…) la società non può permettersi di perdermi (…) mica mi sono trasferito dalla UCLA alla Stanford per rassegnarmi».
Altro momento assolutamente centrale, sono le sei pagine anodinamente intitolate MATTINO. Il protagonista parla di sé attraverso oggetti: televisore, creme e idratanti, attrezzi per la palestra, shampoo, dopobarba, impianto HI-FI, mutande, boxer, acqua minerale, pasticche, forno a microonde, sciarpa. Il tutto descritto minuziosamente: profilo, estetica, efficacia, moda, valore economico e immateriale. E soprattutto: trionfo assoluto, felicemente esaltato, turgidamente identificatorio del brand. Ed è proprio con gli anni Ottanta che la cultura della marca assurge al rango di statuina dei penati di epoca romana, icona russo-ortodossa, santino cattolico apostolico romano, sura dal Qu’ran o midrash dalla Torah. La marca giusta, di moda ma elitaria, la più cara e prestigiosa possibile è l’ombra splendida di un’esistenza perfetta.
I personaggi dell’alta borghesia finanziaria e bancaria newyorkese fanno di tutto per essere identificati con gli happy few. Le masse di microcefali possono solo ammirare i «felici pochi» illudendosi di possedere una vita all’ombra degli squali dell’American dream.
Quello che potrebbe essere il sigillo al romanzo, anche se si trova poco oltre la metà, è la scena dell’uccisione di una ragazza ospite nel mega appartamento yuppie del suo carnefice. In due pagine Ellis si scatena in un lento, esasperante rito di “ultraviolenza” (l’avrebbero chiamata Anthony Burgess e Stanley Kubrick di Clockwork Orange–Arancia Meccanica) a base di colpi di sparachiodi. Ovviamente «nuova di zecca» e tirata fuori da «un armadio di rovere Anholian».
Una delle colpe irreparabili di cui si è macchiata la sventurata?
«Un’altra cosa, le gridò. Questo è un vestito Armani. Giorgio Armani! E tu, l’accusò, guardandola con disprezzo, tu l’hai scambiato per una volgare confezione Henry Stuart (…) Brutta sporca puttana troia!».
Ovvero, come fare la festa agli anni Ottanta di yuppie e Reagan e Thatcher e della Rolex – che effigia immancabilmente il polso del serial killer. La lucidissima analisi di Ellis non poteva, dunque, che essere spacciata per scandalosa e insostenibile.
Ma quale può essere la parabola editoriale di uno scrittore che crea a diciott’anni il suo primo libro? E quando lo pubblica, a ventuno anni, diventa subito un capolavoro acclamato come Meno di zero? Portato in Italia da Pironti e tradotto da Francesco Durante: «Tullio Pironti si prese i diritti dietro segnalazione di Fernanda Pivano. Non avevo mai tradotto nulla, ma accettai. Non fu facile. Ellis scriveva impastando lo slang giovanile californiano. Per stargli dietro feci ricorso a una amica losangelina che conosceva la lingua delle Valley girls. La traduzione piacque persino a Pier Vittorio Tondelli».
Non siamo davanti a una macchina progettata per sfornare un gioiello letterario ogni paio d’anni. Dal 1985 a oggi escono infatti sette romanzi, una raccolta di saggi e due sceneggiature. Del ritmo editoriale si lamenta spesso Ellis, ritratto dell’artista da giovane insoddisfatto – echeggiando Joyce. L’ultimo romanzo (Imperial Bedrooms) risale al 2010. Poi più nulla. Un calcolo veloce mostra un ritmo di tre anni e mezzo per ogni libro; dieci in trentacinque anni.
Forse Ellis è un tipo complicato? Molto più, a leggere varie dichiarazioni. Famoso è l’attacco a David Foster Wallace, che coglie nel segno: facendo indignare i fan dello scrittore divenuto di culto. Perché Ellis è uno scrittore fuori dal tempo, non sente l’appartenenza al tempo presente, apparentemente disprezza il passato e dice di un futuro che è peggiore degli altri due tempi insieme. Seguono una lunga serie di dichiarazioni, che vanno a formare l’ultimo lavoro ellisiano: una raccolta di saggi, interventi, riflessioni, recriminazioni.
Ecco qualche esempio estratto da Bianco (White, 2019):
- attacca comunità e ideologia LGBT (Lesbian, gay, bisexual, transgender) – si consideri che lo stesso autore è gay;
- critica ferocemente i liberal statunitensi;
- denuncia la fissazione contro il presidente Trump;
- se ne frega della propria reputazione, pagandone le conseguenze;
- attacca con forza intelligente e sarcasmo creativo il fenomeno della likeability, paradigma primario del social networking – ovvero il fissarsi sui like e altre manifestazioni di pseudogiudizi, in realtà improntati a superficialità in quantità industriale ed equivalente ipocrisia;
- non ama i millennials: irrimediabilmente affetti da political correctness. e che vedono a ogni angolo di strada letteraria o giornalistica o accademica: l’ombra funesta di razzismo, omofobia, maschilismo, islamofobia, antisemitismo;
- altro nemico, lo si può facilmente desumere dai punti precedenti, sono i social che a giudizio dello scrittore losangelino vogliono silenziare ogni idea controcorrente;
- senza il vittimismo dilagante da una ventina d’anni, senza “com” e iPhone, senza il terrorismo per la prima volta nel centro di New York, si vivrebbe ancora, nostalgizza Bret Easton Ellis, l’età dell’innocenza dei suoi 10/15 anni;
- non mancano moltissimi riferimenti (positivi, negativi, salomonici) al cinema e a decine di pellicole fra anni ’60 e ’90.
Sempre in Bianco le pagine più belle e interessanti sono quelle dedicate alla preparazione di American Psycho. Con ricche analisi sociologiche e di psicologia individuale e di massa sui tardo yuppies, cui si ispira per il romanzo.
A Fernanda Pivano, che lo intervistava in Viaggio americano (Bompiani, 2001), Ellis spiegò che chi non apprezza American Psycho non ha apprezzato gli anni Ottanta, e lei commentò, qualche pagina dopo, sull’essenzialità della gioventù di quegli anni: «vita vacua, demotivata, disimpegnata, divorata dal consumismo». Invece, Furio Colombo scrisse che il romanzo era «agghiacciante, insopportabile. Ma queste cose accadono tutti i giorni e la gente fa finta di non saperlo».
Schegge delle sue intuizioni sulla borghesia si ritrovano nei primi anni duemila in Jonathan Franzen e Le correzioni; e tracce della sua lezione in Rick Moody e in Tempesta di ghiaccio (1994) ma con il compito di evocare la buona borghesia intellettuale di prima metà anni ‘70. A fare da eco di quel che Ellis rappresenta per gli ’80 è decisamente Don DeLillo con Cosmopolis (2003), ritratto tanto cronachistico quanto utopiconegativo (o distopico) della fauna di Wall Street a pochi anni dalla crisi del 2007/08, fra globalizzazione e trappola subprime. Invece il suo antenato è sicuramente Philip Roth di Pastorale americana (1997) anche se il libro esce dopo, in una distopia che piacerebbe ad Ellis, o forse no.