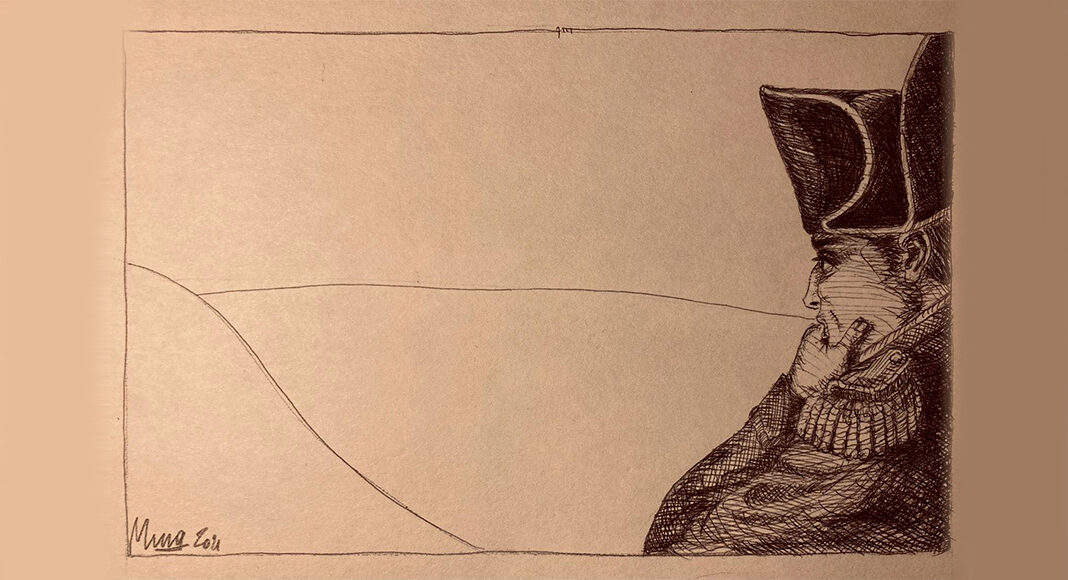«Se desiderate mangiare bene, mangiate con Cambacérès, se desiderate mangiare male, mangiate con Lebrun; se desiderate mangiare in fretta, mangiate con me».
Napoleone Bonaparte al Generale Thiébault
«Non ho tempo», ripeteva Napoleone a Giuseppina che gli chiedeva di trattenersi per il pranzo qualche altro minuto. Mezz’ora al massimo, non di più. «J’ai pas le temps», insisteva Napoleone spiegandole che, dopo dieci minuti, gli sembrava corruzione del potere. Oltre la totale dedizione a quest’ultimo e a se stesso, il rapporto di Napoleone Bonaparte con i piaceri della tavola è condizionato dai dilanianti dolori che prova allo stomaco, effetto del male che lo porterà alla tomba a cinquantun anni e che aveva ucciso suo padre Carlo neanche quarantenne. Dolori curati con frequenti digiuni, diete singolari, l’utilizzo di limonata calda e Chambertin prescritto dal medico curante per quindici anni, da bersi, se non proprio esclusivamente, come vino del privilegio. Più di un privilegio, perché quello proveniente dal Campo di Bertino era già considerato il re dei vini e così descritto dall’Abbate Arnoux nel 1724: «a mon gré le plus considerable vin de toute la Bourgogne». Neanche 13 ettari di vigna piantata a pinot nero, oggi suddivisa tra ben 19 produttori, al fianco della più antica al mondo, il Clos de Bèze, esistente dall’anno 630, villaggio di Gevrey. E mentre Giuseppina insisteva affinché si trattenesse e Napoleone rubava un ultimo sorso di Chambertin, i valletti servivano agli ospiti del Castello di Malmaison alcune delle tredicimila bottiglie custodite nella cantina. Ne abbiamo un preciso inventario redatto alla morte dell’imperatrice nel 1814: il meglio proveniente dal Bordeaux, dalla Borgogna, dalla Champagne e dal Languedoc-Roussillon, le eccellenze iberiche e quelle italiane come il Picolit, il Vermouth e il Rosolio, i vini liquorosi provenienti dal Mediterraneo, dal Reno, dall’Ungheria, oltre trecento bottiglie di Rum e liquori della Martinica, suo paese natale. In pochi anni aveva costruito una delle cantine più pregiate al mondo: purtroppo andrà distrutta qualche decennio più tardi. L’unica bottiglia appartenuta a Napoleone arrivata intatta ai giorni nostri è uno Sherry o un vino di Malaga, sembra del 1810, contenuta nel corredo della carrozza abbandonata nella ritirata da Waterloo. Carrozza requisita immediatamente dai prussiani del maggiore von Keller, e inventariata il giorno seguente, 19 giugno 1815: «L’interno di questa straordinaria vettura merita particolare attenzione, perché è adattata a tutte le finalità di un ufficio, una stanza da letto, uno spogliatoio, una cucina e una sala da pranzo». In una cassetta di mogano per liquori furono trovate due bottiglie, una contenente ancora rum e l’altra un vecchio vino di Malaga. Da quel giorno la carrozza si separa dal suo contenuto. La prima sarà acquistata e rivenduta varie volte, passando per le mani anche di Madame Tussaud, ed andrà distrutta in un incendio nel 1925. La bottiglia di vecchio vino di Malaga, con impressa la N coronata da una ghirlanda di alloro, il cui contenuto si è ridotto di diversi centimetri rispetto al tappo, è stata battuta all’asta nel 2015 da Christie’s a Londra per il valore di 25.000 sterline.
*
«Nel 1814, quando l’Europa in armi marciò compatta contro la Francia, tutti i capi di quella moltitudine non avevano che un grido: Parigi! E, a Parigi, chiedevano dove fosse il Palais Royal, e, una volta arrivati al Palais Royal, qual era il loro primo desiderio? Quello di mettersi a tavola».
Eugène Briffault, Paris à table
Dalla fine del Medioevo, la parola ristorante sta a indicare quei ricchi brodi nella cui composizione entrano pollame, manzo, diverse radici, cipolle, erbe, e, a seconda delle ricette, spezie, zucchero candito, pane abbrustolito o orzo, burro, oltre a ingredienti insoliti come i petali di rosa secchi, uve di Damasco e ambra. Un altro nome del bouillon, il bollito. Di ristoranti o brodi ristoratori, a Parigi, nel 1766, se ne posso trovare da Mathurin Roze de Chantoiseau che apre una bottega in rue Saint-Honoré nei pressi di Palais Royal. Diderot ci andrà spesso e scriverà che «vi si mangia bene, ma a caro prezzo». Chantoiseau è il primo ma non l’unico, seguiranno l’esempio Véry, Méot, Beauvilliers e non si limiteranno a servire brodi. Jean-François Vacossin, secondo ristoratore di Francia, nel suo menu prometteva «polenta bretone, crema di riso al profumo di fiori d’arancio, semolino, uova fresche, frutta di stagione, conserve dei fabbricanti più famosi, burro e formaggi freschi». Sono assolute novità, compreso lo stesso menu, perché fino allora, se volevi mangiar fuori a Parigi, al massimo potevi andare a una table d’hôte. Una grande tavolata pubblica, con menu fisso, dove mentre mangiavi ci si aspettava che chiacchierassi e scherzassi con gli altri commensali, anche se erano sbronzi e puzzavano di birra. Per fortuna, se eri donna non potevi entrarci, e nel resto d’Europa non era molto diverso, fatta eccezione per le taverns londinesi. Anche se era il nome di una cosa da mangiare e non del luogo dove farlo – solo nel 1835 l’Accademia, nel Dictionnaire, ufficializzerà l’uso del termine anche in questa accezione – centinaia sono i ristoranti che prima della Rivoluzione offrono uno spazio dove puoi entrare quando vuoi, mangiare quel che vuoi, scegliendo da una lista di piatti limitata ma sufficientemente ampia, sederti al tuo tavolo con gli amici e dire anche che lo fai per la salute. E, proprio per questo, è consigliato dai medici anche alle donne che debuttano in questo luogo sociale. È nata una nuova cucina, come era chiamata, anche se difficile da definire, ma tutti erano concordi sul fatto che fosse più semplice, faceva bene, ed era consumata solo dai migliori, come capita sempre alla nouvelle cuisine. Nacque nei pressi o sotto le arcate dei portici del Palais Royal, che Filippo duca d’Orleans, noto con il soprannome di Philippe Egalité – inventore del radical chic che gli costò la testa – nel periodo pieno di speranze precedente alla Rivoluzione decise di dare in affitto ai mercanti. Modiste, sartorie, librerie, ma soprattutto i ristoranti e i nuovi cafè dove si mangiava e beveva, lo resero il primo centro commerciale moderno, la zona dello shopping dei Lumi. La Rivoluzione farà da detonatore al fenomeno, tanto che alla fine del periodo napoleonico a Parigi si conteranno migliaia di ristoranti. Accadde, come scritto da più parti, perché molti cuochi di corte si ritrovarono senza lavoro, ma soprattutto perché una delle prime leggi promulgate dall’Assemblea Nazionale nel 1789, fu quella che legalizzava la vendita di caffè, vini e liquori nello stesso locale. Prima lo smercio del cibo e la sua somministrazione erano regolati da riti e privilegi, suddivisi tra corporazioni e aristocrazia. Abbattuti i monopoli, per la prima volta in una mescita dove si vendevano alcolici, si potevano vendere anche altre cose da ingerire. Come ha osservato, con acume, Adam Gopnik, «la neonata cucina francese crebbe nella simultanea presenza di alcol e caffeina, fondendo così, in sequenza, le due droghe con cui i moderni danno forma alle loro esistenze. Dal mattino alla sera, una ci accelera, l’altra ci rallenta e il buon cibo si colloca nello spazio compreso tra esse. Il vino ci porta via dal mondo, e il caffè ci riconduce lì. Nel mezzo, mangiamo».
*
«Le belle arti sono cinque e cioè: la pittura, la scultura, la poesia, la musica e l’architettura, che ha come ramo principale la pasticceria».
Marie-Antonin Careme
«Quel capannone impudico, sfrontato, risonante di voci e di una folle allegria», come descriveva Balzac il Palais Royal, contava nel 1805 almeno una ventina di cafè. Il Cafè de Foy occupava non meno di sette interi archi del portico, c’era poi il Café de la Régence, il Cafè de Chartes, al numero 12 il Cafè Corazza, uno dei preferiti di Bonaparte, che amava recarsi anche al Café Le Procope, fondato un secolo prima da un emigrato siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli, inventore del sorbetto. E a Napoleone, il sorbetto, piaceva. Nelle sue passeggiate sotto i portici indugiava davanti alla pasticceria di Sylvain Bailly e dalle sue vetrine poteva ammirare le pièce montée, riproduzioni di fontane, chioschi, piramidi, templi di pasta decorata, alte fino a un metro e mezzo, realizzate da un giovane apprendista diciottenne: Antonin Careme. Le noterà anche Maurice Boucher, cuoco personale di Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord: ex vescovo e principe di Benevento, servì la monarchia di Luigi XVI, la Rivoluzione nelle sue varie fasi, l’impero di Napoleone Bonaparte e poi di nuovo la monarchia, quella di Luigi XVIII, fratello e successore del primo monarca servito. Per questo è detto “L’anguilla”, “Il diavolo zoppo”, “Il camaleonte” e “Lo stregone della diplomazia”, nondimeno è un preparatissimo gourmand ed è convinto che la diplomazia passi dalla gola: essendo consigliere e ministro degli Esteri di Bonaparte, la cosa non è affatto trascurabile. Talleyrand prende Careme sotto la sua ala, lo fa crescere attraverso varie esperienze (si preoccuperà dei principali banchetti di corte, del menu di nozze di Napoleone, sarà cuoco di Paolina Bonaparte, e così via), e poi lo spedisce allo Château de Valençay, in Loira. È il castello di famiglia, nonché, su ordine di Napoleone Bonaparte, il Ministero degli Esteri francese dove sono ospitati o tratti in arresto i principi e i re d’Europa, affidati alle cure di Careme, a cui Talleyrand intimerà di creare una nuova ricetta per ogni giorno. Sarà questa esigenza a spingere l’inventore, tra le altre cose, della sac à poche, dei vol au vent, del brodo da viaggio sotto forma di gelatina, cioè il dado, a raccogliere e sistematizzare le ricette che la nuova cucina francese stava producendo in quegli anni. Tuttavia, prima ancora delle ricette, c’era il problema del servizio. Fino all’epoca di Napoleone Bonaparte, il servizio più in voga era quello che si definisce alla francese, l’equivalente dei moderni buffet, ma se è possibile, con maggiore confusione. Il pranzo era suddiviso per servizi e prevedeva che le portate fossero già sistemate tutte in tavola e che ogni commensale si servisse a piacimento di quello che più gradiva. Al termine del primo servizio si toglievano i vassoi e i grandi piatti e si disponevano di nuovo contemporaneamente tutte le portate del secondo, finito il quale si lasciava una nutrita serie di gelatine, formaggi e dessert. L’alternativa che lo soppianterà è il servizio alla russa, dove la tavola risultava già apparecchiata con piatti, bicchieri, saliere e tutt’al più gli antipasti freddi. I valletti portavano a ciascun commensale il piatto contenente le vivande – in porzioni singole o da vassoi da cui servirsi – che erano uguali per tutti e venivano offerte secondo una successione stabilita in precedenza: finalmente cibo caldo già suddiviso in porzioni direttamente dalla cucina. Il passaggio dal servizio alla francese al servizio alla russa, come rileva lo storico Jean-Louis Flandrin, è un processo molto più complicato di quanto sembri, una trasformazione in cui i nuovi ristoranti ebbero una parte importante, ma chissà perché si fa risalire a un giorno preciso del 1810, a un banchetto che si tiene a Clichy, alle porte di Parigi, a casa dell’ambasciatore russo Aleksej Borisovič Kurakin e di cui si occupa, ovviamente, Antonin Careme.
*
«Giuro che il mio stomaco non sopporta la nuova cucina. Non sopporto le animelle che galleggiano in una salsa salata né un polpettone di tacchino, lepre e coniglio, che sogna di essere preso per un’unica carne. Non mi piace il piccione trattato come una rana. Quanto ai cuochi, non saprei come tollerare l’essenza di prosciutto, né l’eccesso di spugnole, funghi, peperoncino e noce moscata con cui ricoprono carni di per sé sane».
Voltaire, lettera al Conte d’Autrey
Almeno due dei più famosi e ammirati ristoranti del Palais Royal erano orgogliosamente provençaux: Les Trois Frères Provençaux gestito dai tre fratelli Maneille, Trouin e Simon e il Boeuf à la Mode fondato da due fratelli marsigliesi. Antoine Beauvilliers, per gli anglomani della buona società, aveva aperto in rue de Richelieu la Grande Taverne de Londres. Il baccalà alla provenzale e la bouillabaisse, o qualcosa di simile a meno di immaginare di trovare degli scorfani e del pesce San Pietro in quegli anni a Parigi, potevano sembrare esotiche o à la mode come oggi possono esserlo il couscous e il Maghreb. Quando Brillat-Savarin afferma che un pasto parigino poteva essere un insieme cosmopolita, intende dire che c’era dentro tutto: la cucina delle province, il Sudovest e la Borgogna, i ricordi di quelli che hanno viaggiato oltremanica, ma ancora più la cucina e i prodotti dell’Africa, dell’America e dell’Asia. Cucina francese equivaleva a un composto travestito da totalità, della cui organizzazione e sistemazione, a partire dai suoi brodi, si occupa Careme pubblicando, dal 1817, La cucina parigina, l’arte della cucina francese nel Diciannovesimo secolo (de Kerangué & Pollés Libraires-éditeurs). Dopo aver cucinato al Congresso di Vienna, che passerà alla storia come il congresso danzante anche per via dei suoi banchetti, per Alessandro I zar di Russia – un ingaggio principesco da 2.400 Franchi al mese –, per Giorgio IV d’Inghilterra e per i principali banchetti d’Europa, dopo aver dispensato consigli culinari a reggenti e amici come Gioacchino Rossini, morirà a 49 anni a causa dei fumi inalati nelle cucine. Se con Careme la nuova cucina francese ha finalmente una grammatica, nel 1825, con la pubblicazione de La fisiologia del gusto, o meditazioni di gastronomia trascendentale di Anthelme Brillat-Savarin, conquista anche un teorico fisiologico e filosofico della sua gastronomia. Termine, quest’ultimo, che appare nel 1801 in un poema – La Gastronomia, l’uomo dei campi a tavola – di Joseph Berchoux. Quel che manca ancora, però, è un linguaggio, finanche una letteratura, che la descriva, la spieghi, e giudichi la nuova cucina agli occhi dei suoi recenti avventori: la borghesia. Il «più goloso fra i letterati e il più letterato fra i golosi» che se ne occupa è Alexander Grimod de la Reynière, autore della prima guida gastronomica che si conosca, antesignana della Michelin. Grimod, trasforma un gruppo di amici che si riunisce ogni settimana per parlare di gastronomia, in una giuria di degustatori con il compito di giudicare gli alimenti in vendita a Parigi. Una dozzina di giurati che si riuniscono ogni martedì in cene molto formali con regole severe, con una sola cameriera che riceve le comunicazioni mediante un interfono a tubo. Vengono valutati i cibi preparati da cuochi o inviati da ristoranti e anche alimenti acquistati dai fornitori del mercato di Parigi. Alla fine viene redatto un vero e proprio verdetto di lode o di biasimo che dal 1803 viene pubblicato con il nome di Almanach des Gourmands con le valutazioni che mano a mano vengono estese a ristoranti e fornitori di tutta la Francia. Il successo è enorme (22.000 copie in quattro anni) ed immediato e l’Almanacco sarà pubblicato per ben otto volumi, fino al 1812, quando cessa le pubblicazioni, pare, per i troppi processi che gli vengono intentati. Nel corso dei nove anni l’Almanacco non avrà solo recensioni, ma notizie di storia, ricette, aneddoti, consigli, lettere di lettori. «L’Almanacco dei golosi si indirizza a chi si ritiene o vorrebbe essere un fine consumatore di cibo e di parole» è scritto in epigrafe ad una sua edizione.
*
«È meglio che le beviamo noi anziché i nostri nemici».
Napoleone Bonaparte al maresciallo Berthier
Il 26 gennaio 1814, dopo avere assunto il comando di appena 36.000 uomini e 136 cannoni a Vitry-le-François, Napoleone ordinò al maresciallo Berthier di distribuire 300.000 bottiglie di Champagne e brandy alle truppe. Fate le divisioni e capirete secondo Napoleone di quale e quanto spirito avessero bisogno i francesi per affrontare la battaglia di Brienne e i prussiani comandati dal generale von Blücher. Per invadere la Gran Bretagna aveva stimato che occorressero 150.000 litri di Cognac, accertandosi però della presenza di cantine e di vino in loco. Nessuno meglio di Napoleone, abituato a dividere la propria mensa e i propri vini con le sentinelle e i soldati, sa quanto ne abbiano bisogno le proprie truppe. E se ne preoccupa continuamente. Prima della campagna d’Egitto ordina 4.800 bottiglie di buon vino, per la maggior parte Borgogna rosso, fa vendere 32.000 litri di vino che sta per andare a male e ne ordina ancora: durante tutta la spedizione si calcola un consumo di 4.000 ettolitri, oltre 500.000 bottiglie. Non bastarono, «niente vino, niente forchette e niente contesse con cui fare l’amore», disse Napoleone spiegando il malcontento del suo esercito. Quanto sia importante il vino per Napoleone lo si evince anche dalle sue discussioni teologiche con gli imam per valutare una sua conversione all’Islam: «dopo molti incontri e gravi discussioni al Cairo», aveva ottenuto «la dispensa dalla circoncisione e il permesso di bere vino, a patto che facesse un’opera buona dopo ogni sorsata». A Napoleone pare sia stato conferito anche il titolo di primo sabreur: sciabolatore. Quel che è certo, è che fu pratica istituita dagli Ussari, la cavalleria leggera napoleonica, quella di sciabolare le bottiglie di Champagne per festeggiare una vittoria o augurarsela prima di una battaglia. A procurare le bottiglie, come detto, ci pensava l’imperatore. Nota è l’antica amicizia di Bonaparte con Jean-Rémy Moët, conosciuto nel 1782 proprio a Brienne-le-Château, ai tempi in cui frequenta l’accademia militare e il giovane rampollo della dinastia vinicola, fondata dal nonno Claude, vi si reca per sollecitare gli ordini all’esercito. «Champagne: nella vittoria un merito, nella sconfitta una necessità» sembra ripetesse Bonaparte, che del vecchio amico – già il più grosso negoziante della Champagne nonché sindaco di Epernay ai primi dell’800 – è stato spesso ospite, con Giuseppina, al Petit Trianon. Pare anche che vada sempre personalmente, prima di ogni battaglia, a ritirare le casse di vino. Tranne una volta: prima di Waterloo.