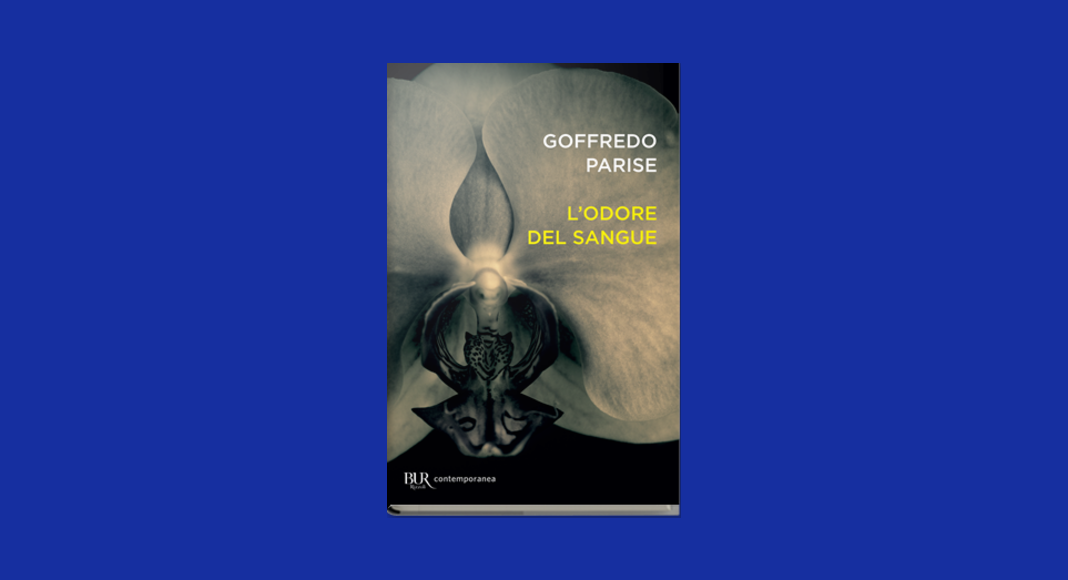Nico Naldini – che di Goffredo Parise fu molto amico – diceva che il suo naso era «l’organo più sensibile della sua rete nervosa, specie di segnavento a forma di becco che lo portava sempre nella direzione giusta». A rileggere la nuova edizione de L’odore del sangue (Bur) a cura di Silvio Perrella, viene da pensare che andando nella direzione giusta tutto va peggio e sempre peggio. Questo romanzo che ha una storia da sommerso e poi da salvato – viene raccontato molto bene anche grazie alla disposizione geometrico-tattica disegnata da Perrella: Dopo-Lodoredelsangue-Prima-Fonti – con tutte le connessioni, i contatti e i rimandi ai Sillabari, e anche al film con Fanny Ardant – e i legami con François Truffaut – che ne trasse Mario Martone.
Un romanzo che non doveva esserci, poi sì. Una storia onirico-ossessiva, scritta nel 1979 (estate) dopo un infarto (primavera), un biglietto lasciato prima di non andare via. Anche se poi, rimessosi, Parise parte per il Giappone e ne torna con un altro libro, L’eleganza è frigida. Sei anni dopo muore. Prima si era dato a una fuga romanzesca con smarrimento di sé. Non lo rilesse fino al giugno del 1986, in agosto se ne andò per sempre. Undici anni dopo il romanzo venne pubblicato. Adesso torna. E si scopre che è invecchiato bene, resiste al tempo, non ha perso la carica erotica, tanto che il percorso della protagonista – Silvia – sembra quello di alcuni film di Lars von Trier (Dogville e soprattutto Nymphomaniac) e le ossessioni del suo compagno – Filippo – insieme formano una coppia dispari che cerca di mettersi alla pari amando due ragazzi. Lei ama un fascista, con impeto borgataro anche se di estrazione borghese, uno che non toglie mai il giubbotto, uno che la domina e sottomette, costringendola a fare tutto quello che non aveva mai fatto – a letto e fuori –. Lui ama una ragazza di provincia, anzi campagna, docile, spaventata, lesionata da un lutto e pronto ad assecondarlo. In un girotondo – che ricorda il Doppio sogno di Arthur Schnitzler che diventa Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick – di gelosie, ossessioni, rivelazioni, desideri, perdite e ritorni, si viene avvolti da L’odore del sangue, retaggio del Vietnam, bene descritto da Parise per mano-bocca di Filippo:
«Ricordavo benissimo questo odore per averlo sentito, per così dire in profondità due o tre volte: subito dopo un combattimento in Vietnam; dove un soldato, ferito gravemente dallo scoppio di una mina, stava dentro un elicottero in partenza. Era un elicottero-ambulanza, con un piccolissimo ospedale di emergenza. Mi trovai così solo insieme al soldato ferito in barella: la ferita, se così si può dire, era tremenda: più che altro un ammasso di carne annerita dall’esplosione e costellata di flussi di sangue. Gli innestarono immediatamente il becco di un enorme flacone di sangue e uno di plasma dentro quello che doveva essere un braccio e l’elicottero partì. Con il turbine di vento sollevato dalle pale il lenzuolo con cui era coperto, a sua volta zuppo di sangue, sbatté per un po’ fuori dal portello aperto, poi finì per essere succhiato fuori e volare verso terra come una bandiera, lenta e a enormi chiazze rosse, di un rosso che è soltanto il rosso del sangue. Fu in quel momento che mi colpì l’odore, un odore molto simile a quello dei macelli all’alba, ma infinitamente più dolce e lievemente nauseabondo, anzi, per essere più precisi, esilarante. Mischiato a quell’odore c’era quello di alcool, di etere e ancora altri ma l’odore del sangue, con la sua dolcezza, con il suo zucchero umano, con la sua linfa, dominava su ogni altro e nemmeno i flussi d’aria che entravano violenti nell’abitacolo, riuscivano a portarlo via: stagnava, nella sua dolcezza, e per così dire parlava; si esprimeva, un po’ come potrebbe esprimersi un quadro. Quell’odore era un’opera d’arte e, proprio come l’opera d’arte, quando è veramente tale, esprimeva soprattutto il mistero, l’attesa, il rimando a capire. A capire che cosa? Non lo sapevo».
e ci si perde nel libro come Filippo dice d’essersi perso su ricordo di Parise in Cambogia, intorno alle rovine del tempio di Angkor Vat:
«Penetrato senza guida nella foresta e facendomi strada con un machete fui preso a poco a poco dal timore di aver perduto la strada, di non poter più tornare indietro né sapere dove andare avanti. Sapevo, certo, che mi trovavo nel perimetro dell’immenso tempio khmer ma sapevo anche che questo perimetro era di chilometri e chilometri, di foresta tropicale, di cui pochissimi percorribili. Non avevo con me la bussola. Tuttavia sapevo che ero entrato da sud, dal frontone principale del tempio e mi ero inoltrato distrattamente da solo verso nord. […] Confesso che ebbi paura. Intorno a me stava, come ho detto, la foresta tropicale, densa di quei suoi immensi altissimi alberi di tek e palissandro, con improvvisi acquitrini su cui volteggiavano milioni di piccole farfalle bianche tutte uguali. Uccelli esotici, di cui non riconoscevo il canto, fischiavano qua e là, nascosti nei viluppi arborei. Di tanto in tanto, dai rami degli alberi cadeva qualche sanguisuga che era l’animale che mi dava più pensiero. Alle volte erano visibili e si potevano sentire nel momento in cui toccavano la tela leggera della camicia, altre volte me le trovavo già appese al collo. Fortunatamente appese in quell’istante e proprio nell’istante in cui si predisponevano a poggiare la loro boccuccia a ventosa sulla pelle e cominciare il loro lavoro di risucchio. Una o due volte accadde e le dovetti staccare, già un po’ gonfie di sangue».
Quando Silvia lo coinvolge nelle sue sens-azioni lui sente l’odore del sangue come in Vietnam e si perde nelle rovine come in Cambogia. Filippo è un ulisside che naviga nelle voglie sessuali di Silvia. Lei è masochista e lui è sadico e viceversa. Lei è masochista nell’assecondare le voglie del ragazzo fascista e lui sadico nel godere delle sue sottomissioni. Lei è sadica nel raccontare le sue avventure sapendo che lui soffre, e quindi masochista nel chiedere e nello scavare a fondo in quelle avventure. La gelosia diventa tortura e conoscenza, dandola e ricevendola. Tutte le pagine risentono di una masticazione che è quella di chi ha il sangue in bocca, quello della fine, è scritto sul trampolino prima del salto, con la percezione della fine, che poi diventa rimando, e riletto alla fine con la percezione del rimando. Ma non c’è più tempo.
Parise è ancora oggi uno scrittore difficile da classificare: eccentrico, isolato, anomalo, uno volutamente ai margini della chiacchiera letteraria anche se ne è il vertice, subito avvolto dal successo – «classico moderno» come dice Giorgio Amitrano –, e subito rimasto infastidito, ma senza perderne l’abitudine, uno che bordeggia la morte per tutta la vita, un naufrago, un ulisside – proprio come il personaggio Filippo –, un introverso, giocherellone, bizzarro, convinto come i bambini che tutto abbia un seguito – basta leggere Il ragazzo morto e le comete – e come tutti i bambini: un indefinito, che nessuna etichetta basta a racchiuderlo. Se Angelo Maria Ripellino era un nonostante, Goffredo Parise è un chissà. Per questo sopravvissuto al darwinismo dell’industria culturale, e per questo capace di affascinare anche Kurt Vonnegut.
L’odore del sangue è una lenta lacerazione che sancisce la perdita, una spirale onirica che diventa reale, la proiezione di un desiderio sommerso, lontano, labirintico, che emerge, diventa concreto: è il sangue evocato, che sale, eludendo il labirinto, è l’immagine del Vietnam che perdendosi nei dintorni del tempio in Cambogia, diventa una scopata a Roma. Prima trasposta, immaginata, sognata e poi realizzata. Il viaggio da piacere immaginato, a dolore provato. Filippo è uno psicoanalista quindi ha tutte le chiavi per capire i comportamenti della moglie, sa le domande da fare e quelle da eludere. Sa dove spingere e dove no. Sa cosa cercare e cosa non vedere. Conosce le dinamiche della doppia coppia che si è creata senza che la loro si sfaldi (apparentemente). Al primo tentativo di Silvia con un giovane studente, lui reagisce riprendendosela, al secondo col fascista sfruttandola. Silvia diventa una trottola: fisicamente nelle mani del fascista, psichicamente nelle lunghe conversazioni a telefono con Filippo.
L’odore del sangue è una traccia da seguire, il lettore la segue, la sente, si spaventa o si eccita, dipende dalle età e dagli stati d’animo. È un romanzo cupo, malato, ospedaliero, eppure pieno di colori, di evocazioni carnali, con un ritmo assurdo che riesce a penetrare, a far sentire il sesso, la vita, l’ultimo desiderio possibile, la passione che riaffiora prima che tutto finisca. Una stagione regalata, e per questo di pazzia.
Finché c’è l’odore del sangue c’è anche il flusso e quindi la vita, quando il flusso cessa, l’odore si consuma, tutto finisce e la vita scompare. In questa circolarità si inserisce Parise, rispettandola, con una geometria di perfezione.
Nico Naldini racconta così l’iniziazione letteraria di Parise: Stazione ferroviaria di Vicenza qualche anno dopo la fine della guerra. Il poeta Fernando Bandini in attesa del treno per Padova sta sfogliando con trepidazione la copia appena acquistata dei Canti di Maldoror di Isidore Ducasse conte di Lautréamont. Sopraggiunge Parise che gli toglie di mano il volume, legge qualche riga e dice: «Questo me lo tengo io». Forse ha letto questa frase: «La Senna trascina con sé un corpo umano. In tali circostanze, assume modi solenni…».
Dalla liquidità della Senna a quella del sangue, scrivendo.