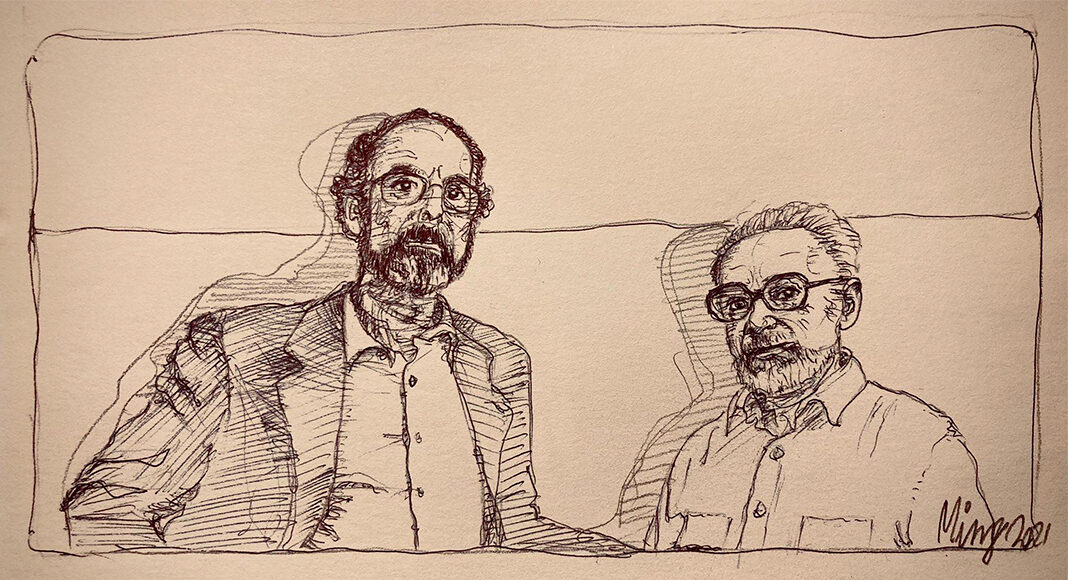Quando Philip Roth va a Torino, nel settembre 1986, per intervistarlo, mancano sette mesi al suicidio di Primo Levi. I due scrittori hanno cominciato a parlare nella primavera precedente, a Londra, e Roth sembra incuriosito principalmente da due cose: della fabbrica di vernici dove Levi ha lavorato e della sua capacità di restare nello stesso contesto – famiglia (la moglie Lucia, la madre e la suocera e i figli a poca distanza), città, quartiere (che gli ricorda la West End Avenue di Manhattan, per il flusso di automobili, bus e tram) e ovviamente fabbrica – per tutta la vita, dopo lo squarcio Auschwitz. Roth è probabilmente il primo scrittore ad aver capito che Primo Levi non è solo il Testimone di uno dei più grandi orrori dell’umanità, la Shoah, ma è uno scrittore fuori dal comune, capace di uscire dal tempo restando sempre nello stesso posto.
Ma c’è anche un pensiero sotterraneo in questo interesse rothiano per il contesto industriale nel quale ha vissuto Levi, un legame altro, tra le macchine, gli utensili, la fila delle cisterne, il laboratorio, e il prodotto finito nei bidoni che poi vanno in giro.
La vernice, il cui odore acre rimane attaccato agli abiti di Levi fino a due anni dopo il suo pensionamento, è il filo che porta ad altro.
Roth vuole vedere da vicino dove e come l’uomo dalle «frasi pregne di intelligenza» è probabile che le abbia pensate, vuole misurare la distanza tra contesto e pretesto e quindi pagina.
E, trovandosi una Torino industriale ancora accerchiata dalla Fiat, pur riscontrando «l’ossessiva geometria torinese», sembra rimanere deluso, e comincia a scavare. Chiede a Levi di tornare in fabbrica, alla Siva, e Levi, tornandoci, dopo dodici anni di pensione, si rende conto che molti di quelli che lavoravano con lui erano morti o in pensione, tanto che quei pochi che riconosceva venivano salutati con: «Ecco un altro fantasma».
Levi sembra condannato a due cose: essere un sopravvissuto, e ritrovarsi circondato dalla parola lavoro: dalla fabbrica ad Auschwitz alla costituzione italiana – primo articolo – e di nuovo alla fabbrica, e poi nelle pagine sempre più o meno autobiografiche dei suoi libri, tanto che, quando Roth gli chiede dell’aroma chimico, risponde: «Lo riconosco e lo identifico, come un cane».
La vernice e il suo odore acre – che poi è l’odore del lavoro, l’aroma chimico – hanno a che fare anche con Auschwitz.
Nel racconto Vanadio, de Il sistema periodico (21 racconti che partono dalla tavola periodica e arrivano alla vita, che ha come esergo: Ibergekumene tsores iz gut tsu dertselyn / è bello raccontare i guai passati) scrive:
«Una vernice è una sostanza instabile per definizione: infatti, a un certo punto della sua carriera, da liquida deve diventare solida. È necessario che questo avvenga al momento e nel luogo giusto. Il caso opposto può essere sgradevole o drammatico: può avvenire che una vernice solidifichi (noi diciamo brutalmente «parta») durante il soggiorno a magazzino, e allora la merce va buttata; o che solidifichi la resina di base durante la sintesi, in un reattore da dieci o venti tonnellate, il che può volgere al tragico; o invece, che la vernice non solidifichi affatto, neppure dopo l’applicazione, e allora ci si fa ridere dietro, perché una vernice che non «asciuga» è come un fucile che non spara o un toro che non ingravida».
La vernice diventa l’elemento per leggere il mondo. La sua chiave.
E il fatto che sia l’ossigeno a dare origine al processo di solidificazione non è secondario. Questo secondo, più tortuoso, percorso è quello che porta all’essenza della letteratura di Levi.
Sempre in Vanadio, si crea un problema di essiccazione per una partita di resina per vernici, e c’è uno scambio tra il Levi-chimico-delracconto del tutto coincidente – o quasi – con il Levi-chimico-delreale e un Doktor L. Müller, il cui cognome evocava il «non dimenticato laboratorio pieno di gelo, di speranza e di spavento di Auschwitz» dove stava con altri due prigionieri specialisti, «simili agli schiavi indottrinati che i ricchi romani importavano dalla Grecia».
L’evocazione avveniva non solo attraverso il cognome, comunissimo in Germania, ma soprattutto attraverso un errore ripetuto due volte. Il comune Müller scriveva «naptenat» e non come avrebbe dovuto «naphthenat» come un altro Müller diceva «beta-Naptylamin» anziché «beta-Naphthylamin».
Vladimir Nabokov, nel suo saggio Nikolaj Gogol’, a proposito della prosa dello scrittore russo dice che «la differenza tra il lato comico delle cose e il loro lato cosmico dipende da una sibilante».
In questo caso tutto passa attraverso due semplici lettere ph, naftenato di vanadio.
Perché poi si scopre che Müller è proprio quel Müller di Auschwitz, uno che chiese a Levi nel laboratorio dell’assurdo: «Perché lei ha l’aria così inquieta?».
Domanda che portò lo scrittore a chiedersi: «Der Mann hat keine Ahnung», costui non si rende conto.
Ma ora Müller è costretto a rendersi conto, perché, mischiato al lavoro, con due treni che partono dalla stessa stazione – la Primo Levi – riceve due lettere: una dove si deve arrendere all’errore della vernice, e l’altra molto più complicata che gli chiede conto dell’errore della sua vita e della Storia. Una dove si trasmettono ordinazione e si contesta la merce. E l’altra dove si chiede conto dell’umanità trattata come nemmeno la merce.
Ancora una volta tutto si mischia e passa dalle vernici. L’errore si era trascinato, per anni, aveva attraversato il tempo, diventando un messaggio tra due persone, l’unica capace di decifrarlo, e quella che lo commetteva e continua a commettere.
Quasi che Levi fosse chiamato a distillare l’errore. Non a caso nel Sistema periodico c’è scritto: «Distillare è bello».
Questo lo riporta anche Roth, colpito dalla soddisfazione del processo chimico e dall’enunciazione leviana. Tanto che definisce la sua intervista con lo scrittore: una distillazione.
E in questo girotondo di odori, quindi di nasi, l’intervista comincia con la descrizione dello studio di Levi, delle cose che ci sono in giro, ma solo una non viene decifrata da Roth. Dietro la scrivania ci sono due pezzi grossi: un uccello-guerriero armato di un ferro da calza e un’altra figura, che Levi spiega così:
«Un uomo che si suona il naso».
Roth aggiunge: «Un ebreo».
E Levi, ridendo, risponde: «Sì, sì, certo, un ebreo».
Le figure appese sono fatte di filo smaltato, perché Levi era tra i trenta specialisti al mondo che si occupavano di smalti isolanti per i conduttori elettrici di rame.
L’intervista comincia dal lavoro, dalla sua centralità che dal Sistema periodico arriva nella Chiave a stella passando per Arbeit Macht Frei, le parole che campeggiano sopra i cancelli di Auschwitz.
Il lavoro diventa parodia, punizione, rivelazione, come se Levi ancora una volta fosse chiamato a distillare anche questo. Riportare il lavoro all’umano. Che è poi quello che fa, e trattandosi di Roth, è chiamato ad ammettere che sì, nel 1942 era «un equivalente sessuale piuttosto che una vera passione».
Poi diventa punizione nel Lager, e solo dopo, i due lavori di Levi (la chimica e lo scrivere) tornano ad avere una importanza fondamentale. Perché distillati.
«Sono convinto che l’uomo normale è biologicamente costruito per un’attività diretta a un fine, e che l’ozio, o il lavoro senza scopo (come l’Arbeit di Auschwitz), provoca sofferenza e atrofia. Nel mio caso, e in quello del mio alter ego Faussone, il mio lavoro si identifica con il problem solving. Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso. Il bisogno del lavoro «ben fatto» è talmente radicato da spingere a «far bene» anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a tirar su muri li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale».
Così Seymour Levov lo Svedese, in Pastorale americana (1997) di Roth ha quella dignità professionale e il senso del dovere come vizio personale e custodisce la cura del dettaglio e la conoscenza profonda dell’intaglio su pelli per fuggire dal dolore familiare.
Ecco che il lavoro diventa vernice, copre la superficie del dolore, colora quello che è grigio. Perché come ci insegna Levi: la realtà non giace mai su un piano solo.
Anni dopo, un amico medico dirà a Levi: «I tuoi ricordi di prima e di dopo sono in bianco e nero; quelli di Auschwitz e del viaggio di ritorno sono in Technicolor».
È probabile che negli anni, Philip Roth abbia pensato a Primo Levi più di quello che raccontasse, fuori dagli anniversari, e meno di quanto ci pensasse il regista Denys Arcand che lo infila sempre in un suo film. E che abbia pensato pochissimo alla vernice, anche se quella loro conversazione, nel lontanissimo 1986, finiva con Levi che raccontava il legame tra Italo Svevo e Alberto Moravia attraverso l’unione di una vernice antivegetativa che preveniva le incrostazioni di molluschi e crostacei per le carene delle navi. Svevo era il direttore commerciale delle vernici Moravia. E sia Svevo, sia Moravia, erano due pseudonimi che coprivano i veri cognomi Schmitz (Aron Hector) e Pincherle (Alberto), vernice, appunto, su nomi da nascondere, evitare, persino dimenticare. E che poi entrambi avessero mutato quel cognome-vernice da una donna ci riporta a Roth e ai suoi recenti problemi dovuti al libro di Blake Bailey, Philip Roth: The Biography, appena uscito negli Usa.
Un libro che gli toglie la vernice, senza togliergli l’essenza.