Collegamento, sintesi e indipendenza. A giudicare dai parametri suggeriti da Juan Villoro, nel romanzo Il libro selvaggio, la mente di Bob Dylan incassa punteggio pieno come poche altre.
Dieci in ogni categoria, riduttivo ricorrere alla lode, meglio al Nobel. Sessant’anni di rivoluzione culturale, tra album e concerti, sparizioni e libri, percorsi in velocità come a bordo del suo pullman per il Never Ending Tour: infinite tappe di un cammino che non esaurisce mai anticonformismo, racconto e assenza di ripetizione.
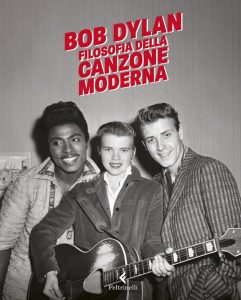
Ultimo snodo che si aggiunge alla sua strada è Filosofia della canzone moderna (Feltrinelli, 2022, pp. 352, con la traduzione di Alessandro Carrera). Più viaggio che saggio, più antologia che analisi. Esattamente come la voce di Dylan, dal momento in cui iniziano a scorrere le pagine, cambia definizione e tratto, timbro e dettaglio. Sessantasei canzoni per sessantasei riflessioni, con destinazione: popular music.
Un racconto intimo
E agli scettici che avranno già sospirato “Un altro libro sulla forma canzone”, si raccomanda prudenza: nessuna formazione al dettaglio di gruppi, nessun Guinness di velocità per accordi suonati, questo non è un libro che si pone come obiettivo e cifra un bollettino arbitrale; i losapevateche e i numeri di copie vendute si lasciano ai giornali che non raccontano più storie e ai Wikipedia che raccolgono dati.
La descrizione e lo sguardo che il cantautore preferisce è un’immersione nel mondo del testo, non ha importanza che sia il dolore operaio da John Steinbeck o l’apocalittico western di El paso.
Da perfetto narratore onnisciente apparecchia e orchestra, illustra e dipinge, come se seguisse il consiglio di Vladimiro Caminiti: “Comincia sempre dal verde del prato e dall’azzurro del cielo“.
Aspetta che il lettore possa visualizzare, sentire, gustare; fa in modo che ognuno riesca a compenetrarsi negli stati d’animo dell’interprete, nella penna di chi scrive. Realizza su carta l’eterno miracolo della canzone moderna: l’immedesimazione.
E la grandezza della scrittura di Dylan è questa universalità che abbraccia tutti, senza distanza. Messo da parte qualsiasi tipo di accademia e nozione, Dylan racconta come se fosse seduto al bancone di un bar, bevendo una birra con ognuno.
Da Modugno ai Clash
Parla di rapine, amori sbagliati e perduti, apparecchi acustici di Johnny Ray, nessi tra Bobby Darin, Frank Sinatra e i fratelli Kennedy. A leggerlo potrebbe essere lo straniero, Sam Elliott, de Il grande Lebowski: nulla gli appartiene ma tutto gli interessa, nulla gli sfugge e tutto tra le mani gli scivola, compreso sé stesso e la sua identità. Ed è proprio alla fine dell’episodio che lascia che la saggezza si affacci: nessuna regola, solo buoni consigli.
Come per Cheaper To Keep Her, una riflessione tra matrimonio e divorzio, umorismo, praticità ed economia domestica – “Costa meno tenersela, davvero” – o per Money Honey tra tempo, arte e denaro – “Tempo fa ho cenato con amico che da poco tempo aveva perso la moglie. Mi disse una cosa che mi fece pensare un bel po’. Disse: ‘Il solo motivo per cui tutto questo ha un senso è perché finisce’” – e nel caso qualcuno voglia impegnarsi nella stesura di una canzone sociale attenzione alle trappole delle rime facili.
Ad eccezione di qualche evergreen – Volare di Domenico Modugno, London Calling dei Clash – la selezione di Dylan segue apparentemente ragioni che la ragione – o la hit parade – non conosce. Sono laterali e dimenticate dal grande pubblico, perdenti e strazianti. In tutte, da cantautore e musicista, riesce a trovare la luce e la miglior angolazione per poterle mostrare.
La fuga come stile di vita
Perché in fin dei conti cosa sono le canzoni se non diapositive, foto istantanee, piccole frazioni di eventi per poter raccontare altro?
Soprattutto quando si tratta di storie di fuga. Che si stia provando stanchezza della routine quotidiana o scappando per furto d’auto o di cavallo, per Bob Dylan non fa alcuna differenza.
L’irrequietezza e la volontà di fuggire sono sempre motivo della sua corsa e delle sue riflessioni: non accontentarsi mai di ciò che si ha o si è, mostrare l’eterno scontento tra nostalgia del passato e insoddisfazione di ciò che il presente o il domani ci riserverà.
Chi si ferma è perduto, o peggio: intrappolato per sempre in un’unica immagine. Unico modo per sopravvivere a tutto questo è continuare a tessere film, canzoni, aneddoti, vite e darsela a gambe. “La gioia di muoversi, di non stare da nessuna parte“, chissà se mentre lo scriveva si è ricordato di essere l’anima di I’m Not There (regia di Todd Haynes, 2007, disponibile su Prime).
Leggendo le pagine dedicate a Johnny Paycheck, alle scarpe blu di Carl Perkins, gli zingari, vagabondi e ladri di Cher ed altri mille racconti inclusi in Filosofia della canzone moderna, aumenta solo la voglia, il desiderio e la febbre di scrivere, leggere e ascoltare al meglio.
Un’antologia che riesce a pacificarci con la narrazione, schiva l’omologazione della scrittura musicale, allaccia canzoni e mondi distanti per proporre nuove visioni.
Un’infinita autostrada in cui ogni sosta è solo per girare pagina e cambiare traccia da ascoltare. Sintesi di immagini, ponti tra universi e libertà di movimento. Ogni requisito esaudito per una mente fuori da qualsiasi schema.
E la strada di Bob Dylan è ancora lunga.


















