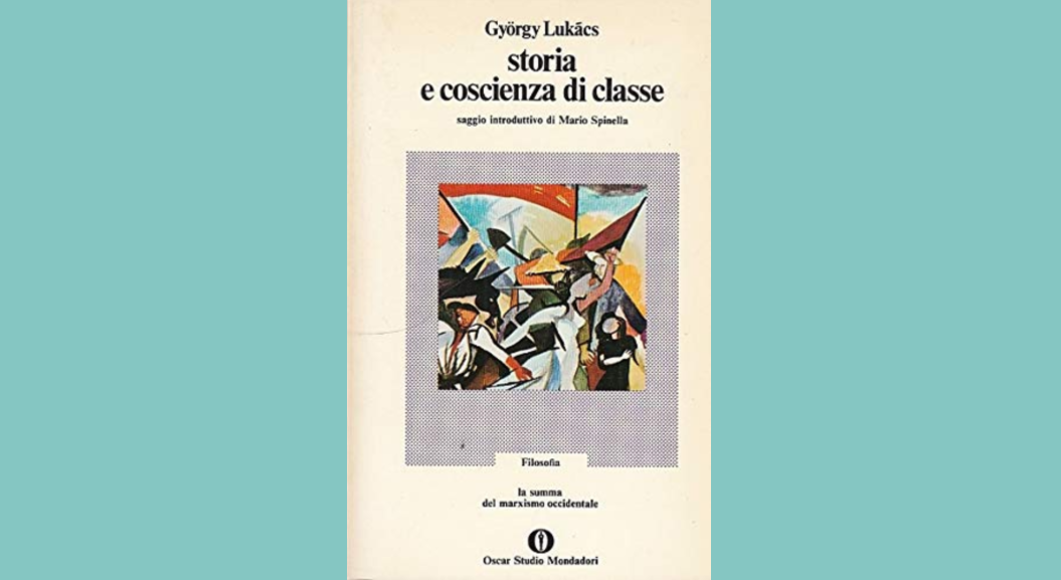In pieno 2021 mettersi a scrivere su un personaggio come il filosofo e letterato marxista ungherese viene in genere scambiato per uno dei seguenti atteggiamenti. Magari allegra presa di distanza: «Figurati che mezzo secolo fa ci si arrovellava su roba simile, coscienza di classe, socialismo realizzato, genio di Lenin e di Stalin». Magari inguaribile gesto di snobismo: «Il presente fa così schifo che non mi/ci resta che riprendere gli autori che tiravano mezzo secolo fa». Magari pruriginoso rimestare fra vecchie carte senza disporre di una bussola per orientarsi.
Sempre, ben intesto, che non si scriva sul quotidiano Il Manifesto o su un sito di vecchi nostalgici del socialismo reale. Mi piace partire da un insospettabile di simili rimpianti come Claudio Magris. Che quarant’anni fa osserva: «Il vecchio Lukács ha scritto Tito Perlini, aveva la sicurezza e l’umiltà di chi si sente portavoce dell’universale e si rende conto (…) che non importa la sua persona, bensì il servizio (…) “Finchè parlava”, diceva Thomas Mann (…) “aveva ragione”. Kafka (…) gli avrebbe potuto insegnare che talvolta si ha ragione quando si tace». (Claudio Magris, Lukács. Il demone della totalità, Il Corriere della sera, 6 giugno 1981, ora in Itaca e oltre, Garzanti, Milano, 1982, p. 128).
Due o tre pennellate al suo ritratto offrono un ambiente di nascita di alta borghesia – padre banchiere di Budapest che riceve dalla corte asburgica l’investitura con il titolo baronale.
Colto, due lauree, con occasioni di viaggiare e frequentare teatri, parlare quattro o cinque lingue (oltre a leggere latino e greco antico), il giovane Lukács ricorda Engels o i sodali della Scuola di Francoforte, Galvano Della Volpe, Lucio Colletti e altri professori di chiara fama legati all’area marxista. Ovvero, l’alta borghesia colta e internazionale (si veda Perry Anderson, Il dibattito nel marxismo occidentale, Laterza, Roma-Bari, 1977). Voglio essere chiaro. Le opere – oltre una sessantina di volumi e centinaia di articoli e saggi e recensioni – richiedono almeno una decina di pagine d’introduzione specialistica. Non è certo questa la sede, e non posseggo certo la competenza richiesta. Sono piuttosto le vicende della vita a costituire un punto di riferimento ancora oggi a mezzo secolo dalla morte. Proprio per gli stessi motivi che lo fanno scambiare per un superato. Certi artisti e pensatori, scrive Massimo Cacciari negli anni Settanta, sono già postumi mentre sono ancora in vita. Si sa già che lasceranno un’eredità. Forse sepolta per un po’ di tempo prima di poterla scoprire.
La parabola Lukácsiana s’intreccia dagli anni Venti alla morte con quelle del movimento comunista internazionale. Famose rimangono le autocritiche: per esempio a Storia e coscienza di classe (nella cui edizione del ’67 aggiunge una classica introduzione per disconoscere la gran parte delle intuizioni maturate quarant’anni prima).
Nel 1921 e ancora nel ’56 Lukács mostra insolito coraggio per un intellettuale internazionale, rispettato professore dell’università di Budapest (presso la quale viene a due riprese nominato con onori e poi cacciato con ignominia). Si unisce, cioè, alla rivoluzione dei Consigli operai, contadini e militari nel ‘21 – sulla falsariga di Pietrogrado, Berlino, Monaco. Quindi, appoggia la rivolta di Budapest del ’56. In ambo i casi riceve nomine politiche in qualità di Commissario del popolo alla Cultura.
Se nel ’21 deve fuggire in Austria, nel ’56 viene invece sbattuto in un duro campo di rieducazione post-stalinista. Come sempre, il pensatore si accoda: non certo per viltà, quanto per poter continuare a respirare l’aria del marxismo, la speranza del rivoluzionamento dal basso di una società che vorrebbe ben più giusta. Un’ostinazione che a volte gli fa rischiare la vita. Si pensi alla permanenza per un quindicennio nella Mosca staliniana, autentica corte shakespeariana piena d’intrighi, morte e denunce.
C’è dunque, proprio nel rapporto fra la vita, le vicende storiche e il pensiero di Lukács, un intreccio che di per sé è specchio di un tentativo di coerenza esistenziale. A volte sicuramente tragica, come si vede dal proprio essere comunista. E restarlo per cinque decenni senza interruzioni, ripensamenti, abiure.
Proprio le autocritiche – per le quali diviene famoso, a volte disprezzato, addirittura preso in giro – costituiscono il banco di prova per la coerenza. Non l’ottusità, né l’opportunismo.
Sia chiaro: l’autore di Storia e coscienza di classe non prenderà mai realmente le distanze dallo stalinismo, dai 27 milioni di vittime del peggior dittatore della Storia – in ciò anche rispetto a Hitler. E senza nulla togliere all’unicità della Shoah. Ma si tratta di una precisa continuità. Espressione, come scrive Lelio La Porta: «Di quelle vite che hanno costretto il pensiero a sottomettersi quasi totalmente alle stesse svolte imposte dall’esistenza storica».
L’ortodossia, quindi, riletta alla luce di un attaccamento lucido quanto affettivo, personale quanto altruistico. Nella convinzione che «il movimento reale che distrugge e innova lo stato di cose presenti» (per parafrasare Marx) sia una possibilità collettiva. Non certo fonte di comodità, carriera, arricchimenti personali.
Si pensi al tipo di vita scelto e praticato dal filosofo ungherese. Abbandona la vita più che benestante – cui è piacevolmente abituato fin dalla nascita – per lavorare da intellettuale, commissario del popolo, membro del movimento comunista internazionale, docente universitario. Abitazioni che siano pratiche e stracolme di libri; magari vicine alla sede di partito dove fa politica, all’università dove insegna, alle redazioni delle riviste per le quali scrive.
Vestiti dignitosi, magari di una misura più larghi del necessario (mai l’opposto), i soldi per giornali in varie lingue, saporiti sigari. E pasti veloci possibilmente intessuti di appassionati confronti estetici, politici, letterari, teatrali e quant’altro.
L’attualità del massimo pensatore dell’Ungheria novecentesca, maestro della da poco scomparsa Agnés Heller (altra coerente lottatrice per i principi di democrazia e progresso) sembra risiedere tanto nella profondità con cui scende a indagare Tolstoj e Hegel, Dostoevskij e Nietzsche, la lirica tedesca del Settecento e il teatro moderno; quanto per la capacità di spaziare fra temi, discipline, stili, aree artistiche facendole incontrare e dialogare; sia per la fedeltà alle sue idee. Intendendo la politica à la Foucault, ovvero biopolitica, modalità di stare al mondo.
Gianfranco Contini intitola la raccolta dei suoi studi su Eugenio Montale con la splendida espressione Una lunga fedeltà (Einaudi, 1974). Anche la vita di György Lukács, legata così in profondo alla Storia e alle idee di Bello, Giusto, Eguale, Diverso, è trascorsa all’insegna di una lunga fedeltà. Perlomeno tentata.