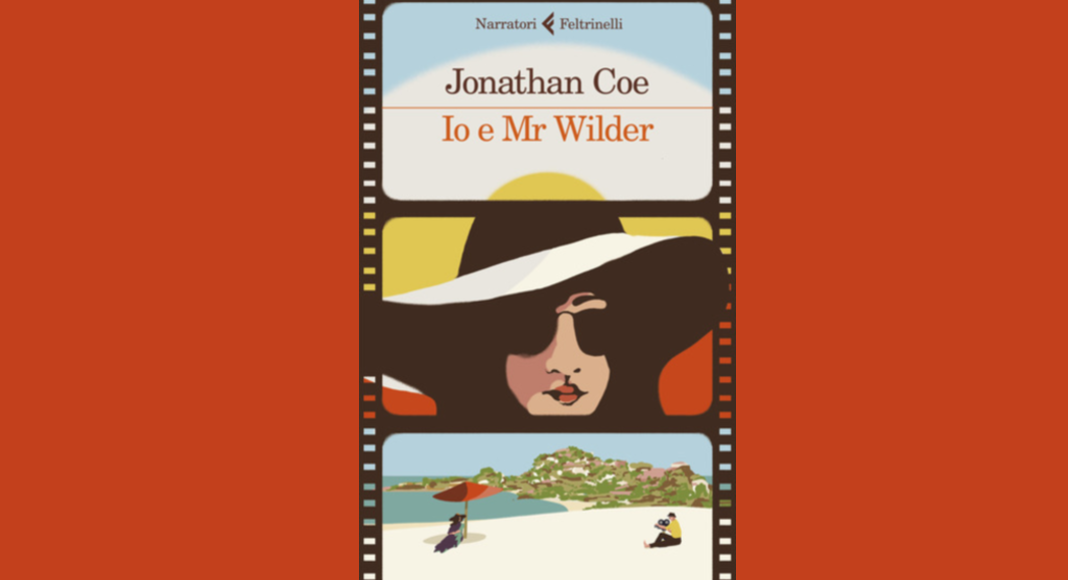Niente è più esaltante che essere spettatori della fine, almeno nel cinema, secondo Federico Fellini. In un’intervista del 1979, il regista racconta ad Eugenio Scalfari che il suo momento preferito durante le riprese è la demolizione del set, una volta girata l’ultima scena: «Tutto il mondo fantastico che abbiamo creato insieme e che abbiamo fatto vivere per settimane e mesi viene distrutto, il cartone e le luci artificiali spariscono. Quest’operazione distruttiva mi dà una gioia indicibile, e me la vedo fino all’ultimo». A differenza del contemporaneo, che vacilla ed è in perenne attesa dell’apocalisse, l’universo cinema, proprio per la sua costruzione, non teme di mettere la parola fine nel percorso: che sia film da fine del mondo, lieto fine o fine di una storia, o anche riscrittura del finale – come fa Tarantino con il salvataggio di Sharon Tate dalla strage di Cielo Drive in Once Upon a Time in… Hollywood – l’epilogo è solo parte di un’eterna rigenerazione, una tappa della dialettica hegeliana, un momento per rinascere e ripartire. Ed è proprio da questa prospettiva, da spettatore di un’apocalisse, da San Giovanni a Patmos in pellicola, che Jonathan Coe nel suo ultimo romanzo, Io e Mr Wilder (Feltrinelli, pagg. 240, euro 16.50, traduzione di Mariagiulia Castagnone), decide di ritrarre il regista di A qualcuno piace caldo e L’appartamento. Un libro-omaggio ad uno dei più grandi artisti del Novecento, ma anche un saggio sulle transizioni del cinema e della vita, e la volontà di non lasciarsi sopraffare.
È il 1977 quando Billy Wilder lavora alla sua penultima opera, Fedora. Una produzione difficile, non solo per i rifiuti degli Studios a finanziarlo, ma per l’avanzata inesorabile della Nuova Hollywood. I grandi schermi sono occupati dai «giovani barbuti», come Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg e il pubblico è interessato a film che scatenano «istinti suicidi» quando si esce dalla sala o a «maledetti squali che fruttano milioni di dollari». Billy Wilder sta già assistendo alla fine del suo mo(n)do di fare cinema, quel desiderio di restituire eleganza per tollerare la brutta vita che attende ogni spettatore al ritorno a casa, ma osserva anche l’evoluzione e la direzione dei gusti nei ventenni: non passerà molto tempo prima che le fauci dello squalo di Spielberg non saranno più sufficienti per terrorizzarli, ma occorrerà impiegare gli artigli dei tirannosauri di Jurassic Park o le mutazioni genetiche dei mostri marini di Jurassic World. Sono le generazioni che non hanno visto la guerra a nutrire questo bisogno di esibire violenza, intuisce Jonathan Coe dietro la voce di Wilder, perché dopo averla vissuta,
«la tragedia diventa parte di te, è lì, non occorre che tu la esprima urlando, che sbatta quell’orrore sullo schermo».
Se la comprensione del cambiamento non sfugge al regista, così come l’abilità di smarcarsi da rimpianti e malinconie, per riscattarsi non gli resta che munirsi di ironia, quell’umorismo ebraico per cui occorrono millenni di persecuzioni – direbbe Devorah Baum con il saggio La barzelletta ebraica – accettare che Fedora sia prodotto dalla Germania, ritornare in Europa per girare dopo essere sfuggito all’Olocausto, restare curioso dei giovani, studiarli e parlare con loro: sarà Calista Frangopoulou, immaginaria traduttrice greca e voce narrante del romanzo, ad offrire a Wilder un punto di vista alieno e la possibilità di conversare con una generazione lontana dalla propria.
È il titolo stesso, Io e Mr Wilder, a suggerire questa dualità che sigilla il buon esito dell’operazione di Jonathan Coe: allo scrittore inglese non va riconosciuta solo una restituzione puntuale di lingua e gestualità, senso del comico e del tragico, ma è tramite il giusto utilizzo del dialogo, nella meccanica della sua costruzione, che avviene lo svelamento della biografia del regista – senza cadere troppo nel didascalico – e la reciproca conoscenza di due pianeti distanti. Billy Wilder osserva e discute con Calista, capisce il futuro e lo accetta, vede la fine del mondo e l’inizio di un altro. La fotografia del passaggio da un’epoca all’altra si trasferisce nella forma che Jonathan Coe sceglie per il romanzo: un ibrido, un’osmosi tra sceneggiatura e racconto che dona velocità alla narrazione, la stessa con cui deve confrontarsi la produzione del film per cambiare set. Francia, Germania, Grecia, il fondale con la scenografia cambia di continuo per lasciare il posto a celebri apparizioni: Al Pacino e Marthe Keller, I. A. L. Diamond e il fantasma di Ernst Lubitsch, Henry Fonda e Miklós Rózsa. La non fiction si collega senza strappi alla creazione, quasi a ricreare il ritmo di entrate e uscite, edificazione e distruzione di un teatro di posa.
E se lo sguardo al futuro di Billy Wilder è chiaro e nitido, la stessa precisione gli viene consegnata dalla scrittura di Coe per quanto riguarda il passato. Sono le immagini dei campi di concentramento che continuano a visitare la mente dell’artista, costretto dalla produzione tedesca di Fedora a tornare a Monaco. Se per George Stevens – come descrive il documentario Five came back sui registi di Hollywood incaricati di filmare la seconda guerra mondiale – l’apertura dei cancelli di Dachau segna in maniera definitiva il suo allontanamento dal musical e dal comico, per Billy Wilder la visione delle pellicole sull’Olocausto marca l’inizio del suo disinteresse per il cinema tragico e della stagione della sua commedia anni cinquanta. Anche questa è la fine di un mondo. Dopo la realizzazione de I mulini della morte (1945), cortometraggio prodotto dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti e destinato al popolo tedesco con materiale girato nei campi di prigionia, Wilder decide che sarà una risata a salvarlo: se non può dimenticare l’apocalisse della Shoah, può creare gioia attraverso una proiezione, perché
«la vita è troppo brutta, lo sappiamo tutti. Non occorre andare al cinema per scoprirlo».
E se una fine deve esserci, tanto vale sorridere.