Mette le mani avanti Ian Penman, e cominciando il suo Fassbinder. Migliaia di specchi (traduzione di Luca Fusari, 2023, Edizioni Atlantide) elenca le cose che mancano come se fosse una canzone, anzi una canzone di Guccini: Quello che non… in parte per impossibilità, ma anche per scelta.
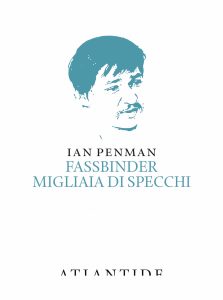
Nessun compendio, nessuna ambizione d’archivio, nessun commento, scheda da Morandini o stelle di votazione per il regista e sceneggiatore, produttore e attore, montatore ma anche drammaturgo e scrittore, che rovesciò e contribuì a creare il Nuovo cinema tedesco.
Un artista difficile da raccontare
Perché Rainer Werner Fassbinder non solo crea ma è soprattutto moltitudine. Un corpo complesso a cui starebbero stretti “una biografia o una panoramica o una cronaca o un resoconto in quest’epoca di Wikipedia, Twitter e tutto il resto di info-mattoncini e archivi iconografici a portata di clic“, meglio tentare l’esegesi, questo “salto triplo“, e mischiarla ad autobiografia, ponti temporali, epifanie di immagini.
“Difficile da canonizzare, difficile da piangere. Difficile da assimilare. È il contrario delle personalità moderniste che lasciano in eredità un pugnetto di frammenti, briciole dopo un pic-nic: il culto del piccolo e del perduto, della scheggia e del pezzetto. Di tutto ciò lui è il contrario. È un’intera città, regione, conurbazione, nazione; die Fassbundesrepublik“.
Sullo sfondo la Germania negli anni Settanta
E difficile diventa non essere contagiati da questa febbre di conquista e scoperta: ciò che muove Penman è amore, ma soprattutto un debito di incredulità fin dalla prima visione di Germania in autunno (1978).
Per questo ne spezza il corpo e ne fa eucaristia, 450 frammenti o specchi per ricomporre e donare Fassbinder, o meglio il rumore bianco che rappresenta.
Perché è solo allargando lo sguardo oltre la filmografia del regista – famelica, con un’opera realizzata ogni cento giorni – costruendo una relazione con le fotografie di Gerhard Richter, vita e racconto di Vladimir Nabokov, i testi di Jacques Derrida, Walter Benjamin e Jean Genet – ma anche le telefonate con Jane Fonda – che si può comprendere Fassbinder e ritrovarsi da contemporanei nel suo riflesso.
Dando priorità al contesto: esplorare la Germania degli anni settanta, condannata all’ombra e alla rovina dopo la seconda guerra mondiale che diventa il laboratorio europeo del futuro, dall’arte alla politica.
Il tema ricorrente del doppio
E da critico musicale, è semplice per Penman garantire l’accesso al “frastuono più atroce” della scena tedesca. Del resto se a Berlino furono attirati come falene David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop, occorre analizzare quella tensione sociale in cui si trovarono coinvolti i figli crepuscolari della sconfitta nazista, il terrorismo della RAF e la società dei consumi. Una complicata sovrapposizione.
E Fassbinder ne è il suo Frankestein: dalla sinistra post-sessantottina alla liberazione omosessuale, dai film hollywoodiani – che gli fanno da genitori nella sala cinematografica che diventa culla – all’ amore per il cinema di Chabrol – che troverà il tempo di rinnegare – dal teatro di avanguardia alla cultura europea.
Multiforme e in espansione come Orson Welles, con il rigore della consegna lavorativa ma lo sperpero dell’uomo. Un doppio Fassbinder “curioso sosia o doppelgänger o riflesso” che non smetterà mai di ossessionarlo: se in Despair (1978) il protagonista Hermann Hermann – un doppio “uomo” – fa l’amore con la moglie Lydia osservando il suo doppio seduto in poltrona, in Querelle de Brest (1982) è Brad Davis a sfidare in un duello a specchio con coltello, in un movimento coreografico, il fratello Hanno Pöschl / Robert giurandosi amore fraterno. “Sii te stesso” raccomanda Robert, “Sto diventando me stesso” risponde Querelle.
E non è un caso che questo scambio ci sia proprio nell’ultima fermata della filmografia di Fassbinder: la riconciliazione con sé stesso e il proprio doppio come tentativo finale. In un cielo senza luce naturale e pochissima aria. E senza nessuna pietà.
Un ritratto mai banale
È un esperimento complesso, un flusso di coscienza per 450 paragrafi che restituisce esattamente il profilo del suo soggetto, il libro che Ian Penman ha voluto consegnare. Eppure la lettura non risente della fatica delle opere che ricercano l’autorialità e la certificazione intellettuale.
A dispetto dell’artificiosità di Fassbinder, la voce di Ian Penman segue la naturalezza del vero scrittore.
Di chi ha pensato, progettato, rimandato la stesura per quarant’anni, per pudore ed eccesso di zelo, e in pochi mesi ha sentito di non poter più sfuggire all’impegno.
Un atto di vero amore nei confronti del cinema che non potrebbe mai perdonarsi di cadere nella banalità. Quello che non è Fassbinder.
















