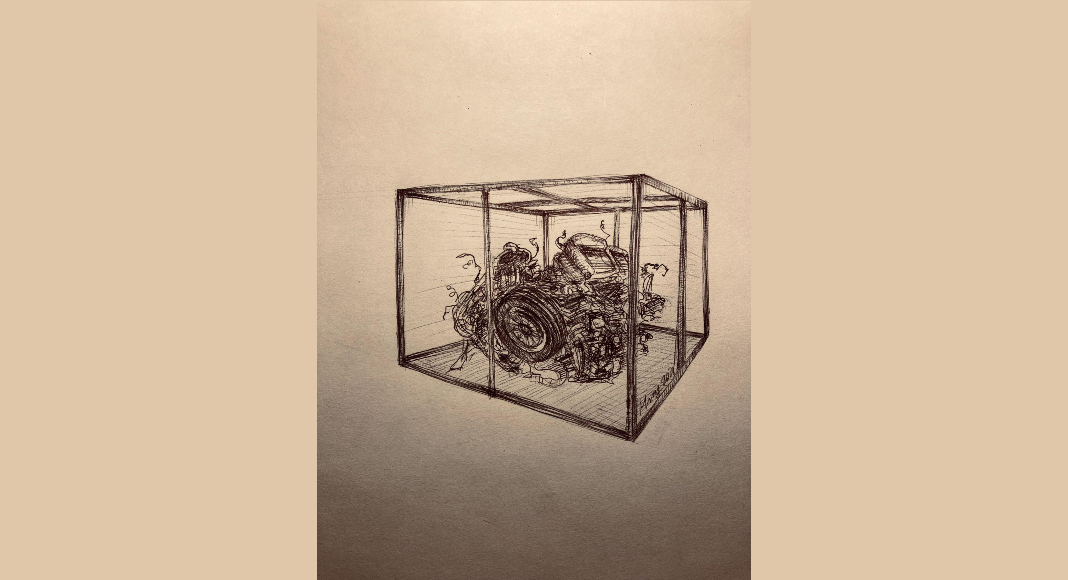Una settimana dopo gli attacchi a Charlie Hebdo andai a Parigi. Presi un aereo a Bergamo e atterrai all’aeroporto di Beauvais, che durante la guerra era stato lo scalo dei velivoli nazisti. Compreso quello che portava Hitler il 23 giugno del 1940. Volevo vedere con i miei occhi com’era Parigi dopo quella strage. Non sono avvezzo a cose del genere, ma quella volta, fui preso da una smania intollerabile. Dovevo fare la ricognizione del dolore.
Alloggiavo in un piccolo albergo nel quartiere latino. Ogni volta che uscivo mi trovavo una specie di lapide in memoria di Michel Foucault, allora costeggiandola iniziavo a recitare i titoli dei suoi libri che avevo letto, come una specie di meditazione, un mantra occidentale che mi teneva compagnia nella discesina che mi portava in un piccolo caffè dove facevo colazione.
Rimasi quattro giorni e di quel dolore che avevo immaginato non trovai nulla. Parigi sembrava distesa, quasi rilassata. Ogni tanto qualche pattuglia con la sirena arrogante che sfrecciava per i boulevard, ma le persone sembravano serene, incomprensibilmente perdute nell’oblio.
La città non sta riprendendo a vivere, pensavo, la città sta dimenticando. Da noi, in Occidente più in fretta si dimentica e meglio è. Questa fu la conclusione a cui arrivai. Quando ne parlai con alcuni amici, mi dissero: guarda che la vita deve continuare, mettendoci anche un risolino a mezza bocca. Sì, rispondevo, la vita deve continuare, ma non puoi mettere via il dolore, non lo puoi scacciare con un gesto, come quando sfratti i piccioni dalla finestra.
Parlando con questi amici mi venne in mente un passo del Macbeth. Malcom e Macduff stanno parlando quando arriva un messo. Sulle prime porta notizie positive, ma Macduff capisce qualcosa e lo incalza. Allora il messo confessa che il castello è distrutto e la moglie e i figli di Macduff sono stati trucidati. Allora Malcom dice: «Fatevi coraggio! Per guarire da questo mortale dolore, serviamoci di questo come medicina, per la nostra grande vendetta… prendete la cosa da uomo!». Allora Macduff, alzando leggermente la testa, replica: «Sì, ma io da uomo la devo sentire».
Esattamente: devo sentirla da uomo. Come ogni dolore. Dobbiamo sentirlo, farlo nostro. Diventa una parte rilevante o poco rilevante, ma esistente, della nostra vita, dei nostri pensieri. S’insinua e si dilegua. Porta avanti le sue ragioni, magari contraddice sé stesso. Ma deve esserci. È il presupposto di ogni vita consapevole.
Ci scrissi anche un piccolo libricino su quell’esperienza parigina. L’avevo intitolato N’est pas facile. Era il grido di un magrebino, platealmente folle, che passava sotto le finestre del mio albergo di notte, verso le quattro. Appena lo sentivo mi affacciavo e lo vedevo camminare lentamente, come se ad ogni passo sentisse il lavoro dei muscoli e delle ossa, il passo silenzioso della desolazione. Mi parve che solo quell’uomo fosse riuscito a sentire il vero dolore della città e a interpretarlo. Era lui che cantava la tragedia, che la portava per le strade ogni notte e la trascinava per la città che invece dormiva nei suoi sogni dorati.
Ritornato a Milano rimasi seduto sul divano di casa per mezza giornata. Ripensavo a Parigi, all’urlo del magrebino, ai sorrisi nei caffè, alle coppie in amore, ai soldati in bassa uniforme, a quella lingua così raffinata e tagliente.
Probabilmente mi addormentai. Sognavo di ritornare sui miei passi, ma capivo da qualcosa che non ricordo che non erano i miei passi, erano i passi di qualcun altro. Di chi? Di un digiunatore, di un bombarolo, di un giovanotto senza pretese, di un cartello di Medellin, di una bomba carta che esplode sotto casa. Erano tutte queste cose insieme. Quando mi svegliai rimasi attonito. Era come se qualcuno nel sogno mi avesse sconfitto definitivamente. Ero lo sconfitto della storia. Della mia storia. Per questo presi a guardare in giro. Sollevai lo sguardo sul soffitto, lo spostai verso la finestra, poi verso la libreria.
Ero solo in casa. Cercai di cucinare, senza riuscirci. Mi sembrava che qualcosa di quel dolore mancato di Parigi mi assediasse il cuore. Una specie di mastino, un molosso senza scrupoli.
Ma io sapevo cos’era. Lo avevo sentito molto tempo prima. Ed era ancora lì a fare i suoi durevoli danni. Era la morte di Giovanni Falcone. L’inizio della discesa. Almeno la mia. La discesa nella disperazione. In quella profonda però, non quella che ci puoi fare i conti tranquillamente, che appena bevi due bicchieri di vino ti lascia in pace, prende il treno delle cinque e ti saluta.
All’epoca vivevo a Roma, in un seminterrato che sapeva di muffa e d’infarti precoci. La casetta aveva un piccolo cortile interno, sul quale gli inquilini dei piani superiori gettavano pacchetti di sigarette, assorbenti, giornali strappati, coni gelato, pezzi di dentiere, spazzole senza denti, catene di biciclette, crotali. Vivevo in quel buco cercando di uscire poco. Facevo la contabilità della mia personale infelicità. La tenevo su un quaderno a righe con la copertina nera. Scrivevo oggi 100, oggi 2, oggi 15. Era una vita insolvente. Come dopo un fallimento. Uscivo a prendere l’autobus, andavo da un barbiere logorroico che parlava di donne, facevo piccoli giri in un parco cittadino scolorato. Studiavo la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso che fra me e me chiamavo Torquasso Tato, e che formava un trio con Ufo Goscolo e Alemanzo Sandroni. Insomma un ginepraio, una specie di colera di là da venire.
Fino al 23 maggio del 1992. Quella è la data della mia diaspora. La strada che invece di portarti a casa viaggia verso l’imbrunire.
Era sabato. Me ne stavo come al solito con le gambe distese a pensare di fronte alla porta del bagno. Si sentivano voci forti dal cortile. Litigi amorosi, ammoniache ingerite di nascosto, lamenti di stanchezza, lunghe diatribe di figli in fregola. Io pensavo ad altro. Facevo itinerari erotici nella mia testa. Programmavo amplessi clandestini. Erano le sette di sera. Fuori ancora era giorno. Era una bella giornata di primavera che faceva presagire lunghe serate amorevoli.
Poi successe qualcosa. D’un tratto tutte le chiacchiere finirono. Dal cortiletto non arrivava più niente. Come se un meccanico fosse arrivato a introdurre un silenziatore nelle corde vocali di quel palazzo chiassoso. Mi alzai dalla poltrona e uscii. Si sentiva, ma lontano, come una voce di donna. Ma era una cantilena che ripeteva parole in progressione di cui non riuscivo a comprendere il nesso. Poi qualcuno alzò il volume e la voce della donna disse Giovanni Falcone.
Mi bastò quel nome per sentire che pezzi di me, ma di un me sconosciuto, stavano svanendo. Una forza notturna, una riserva di prestanza mi abbandonava come si lascia un vecchio in qualche solitudine.
Presi a camminare per il cortile. Andavo avanti e indietro. Da muro a muro, contavo i passi. Poi mi giravo e riprendevo. Guardavo le sagome dei palazzi e li vedevo scivolare. Crollavano silenziosamente, senza spasimi, come in un terremoto gentile, sulla testa, fra i pensieri persi in un nubifragio.
Allora presi le chiavi e uscii. Me ne andai in libreria. Ci rimasi un’ora. Mi sembrava che camminando una gamba non rispondesse bene. Sentivo un dolore fitto al polpaccio. Come se una tagliola che m’avesse catturato vent’anni prima e solo ora iniziasse a mordere.
Quella sera alle dieci venne mia cugina, entrò in casa e mi disse di prepararmi che dovevamo andare in discoteca. Ricordo che non riuscii a dirle nulla. La guardavo. Sembrava mezza nuda. Così, come un prigioniero, mi cambiai e andai con lei. In macchina continuai a guardare fuori, mentre gli altri parlavano a voce alta. Capivo che quella migrazione stava continuando. Una parte del mio cuore stava traslocando. Aveva fatto le valigie e partiva per un lungo viaggio. Al suo posto mi lasciava una specie di affanno, un tormento che sta ancora lì a fare i suoi bei gargarismi.
Era una sala neanche tanto grande con parecchie persone. Noi stavamo in una compagnia di ragazzi e ragazze sorridenti. Si buttavano a ballare come forsennati e ritornavano sudati e metallici. Io rimasi per tutto il tempo seduto. Non riuscivo a mettere a fuoco. Li vedevo, ma sembravano figure geometriche. Logaritmi del divertimento organizzato. Quando li vidi tutti in pista, incollati in mimiche maniacali, me ne andai senza salutare. Presi una strada che si apriva di fronte e iniziai a camminare. Erano le due di notte. Di tanto in tanto passavano macchine a cento allora. Vanno verso una destinazione felice, pensavo. Io invece incedevo con la mia gamba sofferente. Ogni tanto mi sedevo su un muretto e poi riprendevo. Naturalmente mi persi. Sbucai nel quartiere Trieste. Sembrava la ridotta di una dissoluzione. In quel momento avrei voluto che una tigre, un assassino, una guardia giurante, un cappio da una finestra, mi prendesse e mi portasse via, nella sua tana a tagliarmi la gola. Così per interrompere quel tormento. Verso le cinque arrivai a casa. Mi buttai sul letto e presi sonno.
Sono passati molti anni, eppure è sempre qui. Questa specie di slavina, di caduta continua, uno scivolamento del cuore che non trova ostacoli.
La prossima volta che andrò a Parigi mi metterò a cercarlo il magrebino folle. Gli offrirò da bere, berrò anche’io e poi camminando sottobraccio griderò insieme a lui n’est pas facile, n’est pas facile, n’est pas facile.