Da lui un po’ potevamo aspettarcelo. Un vicequestore che quando vede una persona la prima cosa che fa è apparentarla a un animale, riconoscendo nel suo viso i tratti delle bestie più strane, non può che avere una propensione per il mondo naturale. Come confermerebbe Lupa, la cagnona che lo segue docile schiacciando un pisolino sugli scatti caratteriali di quell’umano per niente pacificato con se stesso e con la città di montagna in cui gli tocca lavorare.
Nonostante sigarette, canne, una vita sbilenca e poco soggetta a salutari bioritmi. Nonostante tutto, Rocco Schiavone una certa simpatia per l’Elp non la nasconde proprio.
Se ci fosse una acca davanti sarebbe un grido d’aiuto, scritta così la sigla è un grido di battaglia. Quello che lancia l’Esercito di Liberazione del Pianeta. Un nucleo armato più di buone intenzioni che di armi convenzionali, e al quale però i benpensanti e le forze dell’ordine di Aosta (e non solo) vorrebbero accollare anche qualche delitto a base di sangue.
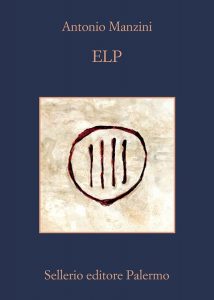
È così che la sostenibilità ambientale colpisce anche il mondo poliziesco. Antonio Manzini nelle ultime gesta di Schiavone scrive di ecoterroristi la cui peggior violenza è disperdere polli o maiali in autostrada, di manifestazioni green in cui ci si riconosce fratelli con il gesto di quattro dita che coprono il volto (la stessa immagine della copertina del libro), di ragazzi sempre più arrabbiati e però dalla parte della ragione nel tentativo di salvare il pianeta.
In questo contesto piazza poi il suo vicequestore, arrivato ormai alla dodicesima indagine letteraria, a partire dal 2013 di Pista nera.
Un personaggio che per i più ha ormai inevitabilmente assunto i tratti stropicciatissimi del Marco Giallini che lo interpreta in tv, con seguito di periodiche quanto vacue polemiche sull’opportunità “morale” di mostrare un uomo delle istituzioni che nel cassetto della questura nasconde spinelli calmanti (ma la sesta stagione, già annunciata con quattro episodi da 100 minuti, secondo l’autore forse non vedrà mai la luce Rai).
Elp – che si apre con i ringraziamenti ai lettori per aver seguito le vicissitudini del vicequestore in questi dieci anni – è uno Schiavone di ampio formato: 544 pagine per due indagini.
Segue un’andatura lenta e riflessiva, in cui Rocco si trova a osservare i giovani dimostranti chiedendosi se un suo figlio avrebbe potuto trovarsi in mezzo a loro, imbracciare i cartelli a difesa del pianeta. Una dimensione intimistica e “indolente” dove l’arrivo del primo morto si fa attendere a lungo.
Perché prima del cadavere ritrovato a due passi dal confine (con Schiavone c’è sempre questo problema: spesso i morti si fanno ammazzare, o ritrovare, lassù sulle montagne e lui non si è ancora deciso a mollare le Clarks per scegliersi calzature più adatte) c’è tempo per divagare.
Con toni malinconici a volte, ironici altre, come nella second story di D’Intino, che si presta a essere preso per il naso e per il portafoglio da una vecchia fiamma con mammà (e dieci valigie) al seguito.
È quello che a opposta latitudine, a Napoli, succede in maniera sempre più evidente a Maurizio De Giovanni, dove il contorno tende ormai a prevalere sul piatto forte.
L’ammazzatina c’è, non potrebbe mancare, e nel nuovo Manzini i morti sono più d’uno, ma a prendere il sopravvento sono le riflessioni dei protagonisti sul vivere.
Riflessioni che inevitabilmente crescono mentre i personaggi invecchiano, tanto che un Rocco appena “docciato” si guarda allo specchio e “notò che il tempo era un’enorme mano che strizzava pelle, ossa e cartilagini, le appallottolava, le raggrinziva fino a ridurlo come la buccia di un frutto marcio, molle e rugoso”.
A nulla valgono peraltro i commenti della defunta moglie Marina, che con il progredire dei romanzi vanno un po’ rarefacendosi, ma che ribadiscono la presenza di quel dolore mai superato.
I passaggi obbligati per chi ama Schiavone ci sono comunque tutti, compresi Furio e Brizio, gli amici dalla fedina non proprio irreprensibile, che stavolta anziché lui coinvolgono un suo uomo. Offrendo al vicequestore l’occasione per una meditazione simil shakespeariana: “Certo rubare è sempre rubare. Al bambino come al mafioso. E allora quello diventa il bivio: rubare o non rubare? E se andiamo indietro arriviamo fino ad Amleto”, ragiona Rocco a fronte dei dubbi di Antonio, che vorrebbe scaricarsi la coscienza alla prospettiva di compiere un furto per aiutare il fratello.
Quanto a lui, quando tutto è chiarito, su una panchina si siede a pensare “al mondo migliore che non si sarà, alla sua età che non gli permetteva più di ritentare, alla condanna che si era inflitto, alla sua solitudine, alla stanchezza e al dolore al collo, e alle spalle, alla merda che aveva ingoiato e respirato e che sembrava non avere mai fine, alla gioia di cui il pianeta era poco attrezzato, alla vergogna di essere anche lui causa di tanto schifo”.
Attenzione, però. Non finisce tutto qui. C’è un ultimo ruggito che pacifica, e che conferma la natura bestiale di Rocco Schiavone.
















