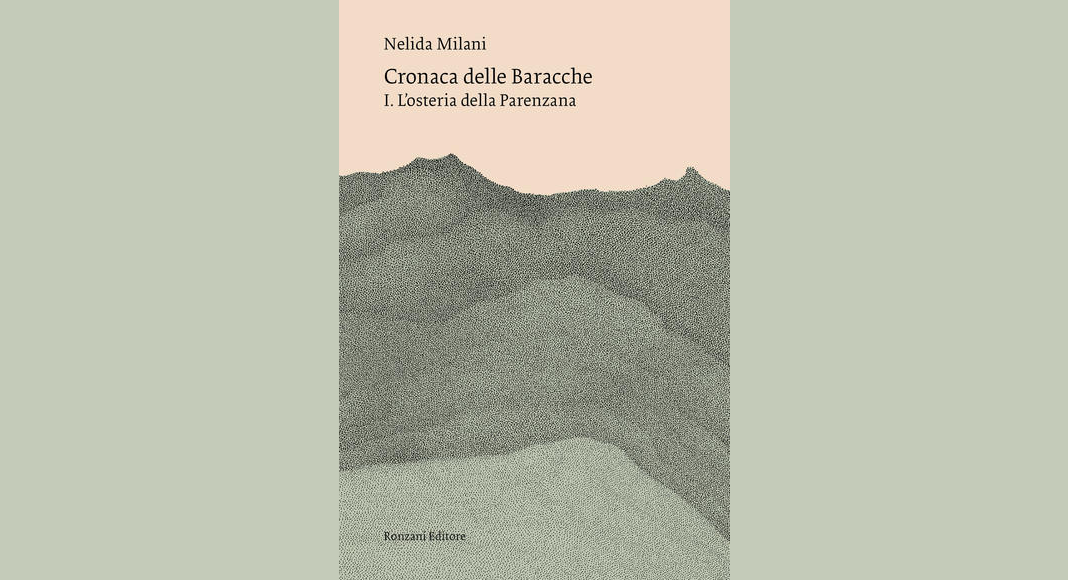Ci sono ancora editori, verrebbe da dire, e scrittori degni di essere letti. Uno di questi è Nelida Milani, che nel primo tomo della saga Cronaca delle Baracche (Ronzani) ci riporta indietro nel tempo, o meglio in luoghi che hanno il sapore di un altro tempo, anche se così vicini, perché come osserva acutamente: «Mi ero convinta che in luoghi diversi si vive in epoche diverse». I luoghi sono quelli dell’Istria, Pola, la città amata che subisce il destino di chi vive sulle frontiere, passando di mano in mano dall’Austria all’Italia, dall’Italia alla Jugoslavia, dalla Jugoslavia alla Croazia… e lungo questa drammatica e insanguinata linea di frattura storica, la scrittrice insegue con affettuosa e ironica partecipazione le vicende di famiglia (delle famiglie), del rione (il quartiere polesano delle Baracche), annotando nel trascolorare dei giorni i minimi accadimenti della piccola comunità, che si vanno a depositare, con grazia dolente così rara da trovare, nel calendario della sua ribalda gioventù.
Scrive nella intensa introduzione il curatore, Mauro Sambi, a sua volta poeta di origine polesana: «Quella di Milani è una voce germinativa, evocativa, di volta in volta delicata, dura, esilarante, straziante o disorientante, che racconta per accumulo, variazione e contrasto una verità che invano (e con una buona dose di cattiva coscienza) si pretenderebbe di far collimare senza scarti e senza eccedenze con quella dei libri di storia». Chi ama questa letteratura autentica, sofferta, che non solo incanta con la limpida scioltezza della narrazione, ma si fa testimonianza e porta a riflettere su ciò che è stato ed è, non può non avvertire l’eco di scrittori come Slataper, Quarantotti Gambini, Stuparich, Voghera, Tomizza, Marin. Ed è un’eco non solo geografica, politica, letteraria, ma di coscienze che sono maturate nella parte in ombra dell’Europa, e persistono nella memoria e nella lingua. Una lingua intrisa di colori dialettali che sono l’anima stessa del popolo che vive, e che nel lavoro, nell’amore, nel dolore, crea espressioni destinate a saldare le generazioni, a plasmarne i cuori e le menti, estraneo a ogni scuola e ufficialità, che infine si sottrae ai regimi e alla loro presunzione di interpretare lo spirito del mondo. La lingua come resistenza, difesa ultima, speranza:
«Nelle parole c’è tutto, quello che sei, quello che mangi, quello che fai, c’è proprio tutto nelle parole».
La lingua salvata, potremmo dire citando Canetti. Tutto il libro è abitato da stralunati personaggi, e dalle loro vicende che prendono forma nelle parole con cui si e ci dicono ciò che provano, e senza cui non sarebbero quello che sono. Ma proprio perché queste vicende intime, di padri, madri, nonni, fratelli e cognati, vicini di casa, prendono risalto all’interno delle grandi e sciagurate manovre della Storia, la lingua si manifesta sullo sfondo del mondo popolare e della sua quotidiana ribellione. E’ centrale nel libro la presenza di un’infanzia difficile, che qui viene colta nella sua elementare e tragica bellezza: «per tutta l’infanzia e anche più avanti abbiamo indugiato nella miseria», e vengono in mente testi come Le ceneri di Angela di Frank McCourt o Di un mondo che non c’è più di Israel J. Singer. Pagine dove non si tace nulla della durezza di vite costantemente alle prese con i bisogni naturali, strette nel cozzare delle passioni e dei sentimenti, lasciando nel lettore un’imprecisa e stordente melanconia, non certo dovuta al rimpianto della miseria, ma di una genuina e innocente vocazione alla vita: «Ma forse proprio soffrire è la grande arte del vivere».
E poi l’esodo, la dolente epopea di chi, dopo la “liberazione”, ha cercato una via di fuga, un cielo e un’aria meno ammorbati da quella opprimente tutela, il regime titoino, che ha fin dall’inizio il carattere di una cappa, evocata in tono sarcastico: «I liberatori sono entrati nella città, gli sarà sembrata la città ideale, credo. Loro esultavano e tutti dovevano esultare, uomini e donne esultanti, vecchi e bambini esultanti, operai esultanti, contadini esultanti, artigiani esultanti, commercianti esultanti. Tutti attorno a me esultavano, non c’era nulla che non esultasse, tutta la città sembrava esultare, le scuole, le fabbriche, gli ospedali, i cimiteri, i tribunali…. Cosa avevamo fatto di male per accettare come giusta e necessaria tanta liberazione? … Non c’era verso di liberarsi dei liberatori». La vita delle persone che sono rimaste dopo il cambio della guardia, è segnata dalla lenta e inesorabile emorragia di coloro che si sono allontanati, che hanno scelto un’altra vita.
L’esodo sognato, vissuto, temuto, a seconda se visto da chi parte o da chi resta, diventa una specie di tradimento per amore, e chi rimane sembra partecipe di un opposto e speculare destino, sembra «che il loro fosse un destino di sentinelle di tombe e macerie, se non addirittura di nessuno e di niente». Attorno a questi assi portanti della struttura narrativa si dispone nel libro un caleidoscopio di racconti, una folla di giovani e di vecchi, di morti e di vivi, ciascuno con la sua storia d’amore, di amicizia o rivalità, e dovrei citare intere pagine di avventure, come quella surreale che vede il giovane fratello di chi narra impegnarsi in un’assurda scommessa con un amico, per una manciata di sigarette, che ha come banco di prova il piccolo Claudio. Buttato in acqua per la prima volta dovrà mostrare di saper nuotare! Tensione, ilarità, lo splendore del mare, lo sguardo di un ragazzo innamorato, sacrifici, beffe, agguati, scorci felliniani, nostalgia teatrale di chi osserva da un vetro come nella Classe morta di Kantor, tutto si concentra nel cuore delle Baracche, nell’osteria della nonna, la Parenzana, luogo magico che riassume il senso della vita comune: «in osteria si viveva sempre al centro di un campo di forze passionali, là si raccontava sempre qualcosa di stupefacente e di misterioso». E come non ricordare Le botteghe color cannella di Bruno Schulz: «ne son passati di qua di Baraccheri con specializzazioni di cose assolutamente prive di praticità, come la follia, l’allegria, l’anarchia, l’ebbrezza, la magnifica noia e l’ubriachezza». L’Istria, terra di italiani che non sono tali, terra di nessuno, in cui i rimasti continuano ostinatamente a vivere, amano la vita, vi si aggrappano con una struggente serenità:
«nelle tenebre in cui sprofonderemo tutti, ci resterà il ricordo di questa dolce luce che splende sul mare e potremo consolarci pensando che questa luce è stata nostra e solo nostra e per tutta la vita».