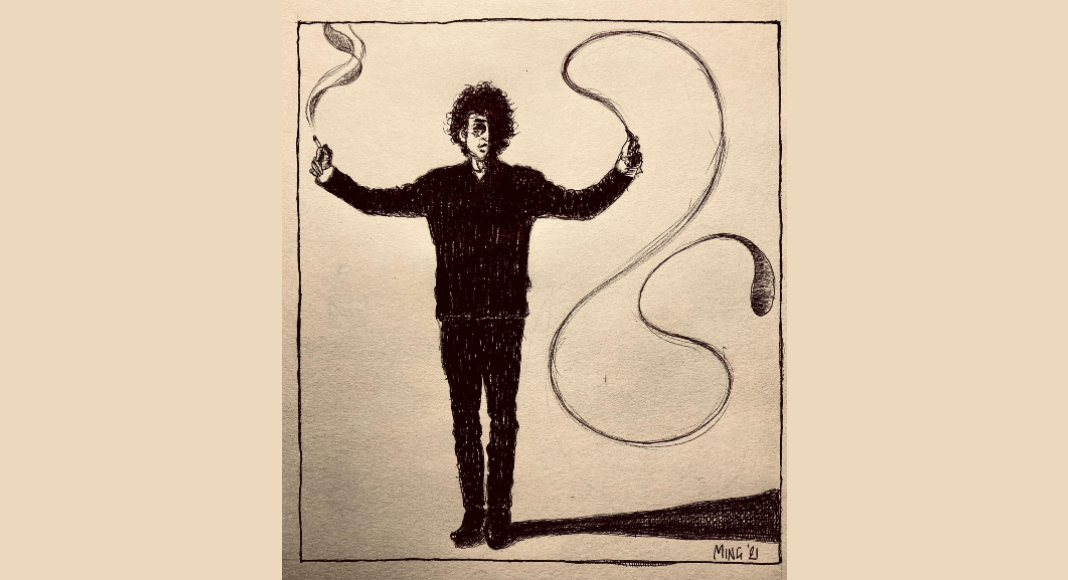All’alba della New Frontier di J.F. Kennedy, nel 1960, in un’America piena di speranze, in mezzo ad una generazione che si affaccia al nuovo decennio vivendo come nessuna prima la potenza dei corpi e aspirando ad un mondo pieno di rischi – passione, sesso, ideali – c’è un giovane che pare non aver alcuna intenzione di attendere il ritorno di Elvis imbottito di benzedrina dal servizio militare. Ecco, Robert Allen Zimmerman ha appena terminato il college e, dopo aver imbracciato decine di volte una chitarra acustica nelle coffe houses del Minnesota per suonare vecchi blues, fa rotta verso New York. Ci va per incontrare e stringere la mano al suo ultimo idolo, il poeta dei diseredati, dei disperati, degli hoboes: Woody Guthrie. L’uomo va spegnendosi nell’ospedale Greystone Park di Morris Plains nel New Jersey, ad appena 55 anni, e Bob riesce a visitarlo e a raccogliere in qualche modo un lascito, riassumibile nel seguente insegnamento: gli uomini sono uomini, null’altro. A partire dallo stesso Guthrie.
Lo spiegherà qualche anno dopo lo stesso Bob Dylan, diventato nel frattempo Bob Dylan (in precedenza era stato altre cose, anche un Blind Boy Grunt). Non è affatto un caso che Guthrie sia il suo ultimo idolo, proprio perché fu il primo a conoscere di persona. Ma cosa di quell’uomo armato di sola chitarra acustica aveva elettrizzato il giovane Bob qualche anno prima, mentre Eddie Cochran urlava la sua Summertime Blues, Little Richard spiegava ad una generazione cosa è il fuoco e come sia piacevole bruciarsi e Elvis muoveva il suo bacino ansimando, piangendo, mugolando? Forse qualcosa che ha a che fare col mistero delle parole pronunciate, recitate ad alta voce, non semplicemente lette. È Guthrie stesso a spiegare l’uso del linguaggio e l’ebbrezza che produceva in lui (e produrrà in Dylan), una sorta di big bang causato dalle parole, dal loro suono: «Ho sentito dentro di me una tempesta di parole, che mi sarebbero bastate per scrivere centinaia di canzoni». È qui che possiamo rinvenire le origini del primo rap della storia, che è Subterranean Homesick Blues (da un album del 1965 che significativamente Dylan intitola Bringing It All Back Home: riportando tutto a casa), un incrocio tra Guthrie, il Chuck Berry di Too Much Monkey Business e il Jack Kerouac de I sotterranei. È qui che possiamo comprendere davvero l’amico e folksinger Dave Van Ronk – quello di A proposito di Davis dei fratelli Coen – quando descrive Dylan nei primi anni ’60 come un posseduto. Non è l’uso massiccio di anfetamine: a possederlo sono i versi, il suono delle parole che gli ronzano nella testa, che martellano, che trasfigurano.
Come Arbasino, Dylan non è un poeta – quelli di solito finiscono male, annegando nei laghi, dirà Bob – e sceglie perciò il rap, il linguaggio di strada, sulle orme del giornalismo cantato di Guthrie.
«I poeti non guidano. I poeti non vanno al supermercato. I poeti non svuotano la pattumiera. I poeti non fanno parte dell’Associazione dei genitori e insegnanti. I poeti non vanno nemmeno a fare picchetti davanti all’ufficio delle Case popolari, o qualunque altra cosa. I poeti non parlano nemmeno al telefono. I poeti non parlano con nessuno. I poeti ascoltano molto e… di solito sanno perché sono poeti! »
L’espressione di Guthrie – tempesta di parole – dice molto. Bob la porterà alle estreme conseguenze, oltre il razionalismo di Woody, con una letteratura che avvicina lo scrivere al parlare, e che è, per citare Gianni Celati, un parlare senza pensare, senza cioè l’ossessione sociale dell’Io.
È probabile che Guthrie rappresenti per il giovane Dylan la ribellione ad ogni schematizzazione, la rottura delle barriere tra arte e vita, tra cultura alta e bassa. Soprattutto, l’uomo che ha influenzato tre generazioni, dai campioni del folk revival come Pete Seeger, ai folksinger degli anni ’60, dunque i Phil Ochs, le Joan Baez, e poi quelli della Beat Generation, fino a Bruce Springsteen, non aveva alcun timore reverenziale verso la letteratura e la cultura ufficiale. Nemmeno Bob ne avrà.
A New York, al Greenwich Village, il ragazzo del Minnesota si innamora della street poetry del nero Big Brown, che si muove nello stesso giro di Larry Rivers e Allen Ginsberg e declama per strada Shakespeare, Walt Withman e Edgar Allan Poe. Si può affermare che l’autore di Blowin’ in the wind abbia a questo punto un’inclinazione per tutto ciò che è semplice e immediato. Preferisce le rime di strada alle letture dei grandi autori, sempre che non siano riproposti da gente come Big Brown e gli altri beatnik anti-intellettuali, e propende per gli accordi semplici di Woody Guthrie in luogo del virtuosismo dell’armonicista blues Tony Glover, conosciuto nel Minnesota. Il suo approccio è decisamente punk, se ci intendiamo sulla valenza da dare alla parola.
A Glover, con cui rimase in contatto, Dylan racconterà i suoi incontri con Guthrie in ospedale, dove al suo capezzale canterà per alcuni giorni e dove nota, stranamente, non c’era nessun altro in attesa di parlare con il suo eroe: «Non ho visto nessun musicista, ma ho visto molti altri uomini. L’unico posto in cui ci si poteva incontrare era nella sala d’attesa. Ci saranno stati 50 o 60 uomini seduti in pigiama. C’erano carte da gioco dappertutto. Ricordo l’odore di quel posto più di ogni altra cosa».
Quando Dylan riceve il Nobel per la letteratura nel 2016, nessuno all’Accademia di Svezia pare abbia citato Woody Guthrie. Che però una trentina di anni prima era stato omaggiato da Springsteen dal vivo con la sua interpretazione di This land is your land, inno ispirato dal New Deal, a suo modo patriottico, sia pure di un’America reale, di vagabondi, proletari, paria colpiti dalla crisi degli anni ‘30.
«Nelle piazze delle mie città ho visto la mia gente fare la fila per il sussidio, e mentre loro stavano lì affamati io pensavo, quanto vorrei che questa terra fosse fatta per te e per me. (…) C’era un gran muro che cercava di fermarmi, e sopra c’era scritto proprietà privata – ma dall’altra parte non c’era scritto niente».
Springsteen appare emozionato ed ossequioso quando nel 2009 la intona insieme alla leggenda Pete Seeger (che all’epoca ha 90 anni) sul palco del Lincoln Memorial dinanzi a Barack Obama. Diversa la interpretazione che ne aveva fornito dal vivo negli anni ’80 – visibile su youtube – dove la fa da padrona la sofferenza dei diseredati e il taglio rimanda alle atmosfere del capolavoro peckinpahiano Nebraska di qualche tempo prima, anticipando altresì quelle di The Ghost of Tom Joad, di una decina di anni dopo.
Per Dylan è diverso. La chitarra ammazzafascisti di Guthrie sarà per lui un simbolo per alcuni anni, successivamente il suo sguardo irrequieto si poserà altrove, archiviando la militanza o comunque trascendendola. Forse quella del cantante folk protestatario è stata solo una maschera. Uno dei tanti travestimenti: il bohémien di Another Side, il country singer di Nashville Skyline, l’artista di nuovo impegnato che canta per il pugile Rubin Hurricane Carter, il predicatore che cita il Vangelo di Luca nei dischi della sbornia religiosa, per dirne qualcuno. La sua stessa storia privata appare forse rimaneggiata sin dall’inizio, col racconto di una incredibile serie di fughe da casa, «A 9, a 11, a 12, a 13 e mezzo, 14, 16, finalmente libero». Che probabilmente vuole solo esprimere la incessante fuga dalle radici, dalle identità, dalle convenzioni. Come Elvis scappa dalle tenebre e dalla miseria delle sue origini, per il tramite di ambizione e genio, anche Bob se la dà a gambe. Da sé stesso. E in fondo anche questo è molto americano, di un’America instabile, imprevedibile, antipuritana.
(A proposito di rimaneggiamenti e fake, Martin Scorsese, dylaniano oltre Dylan, aggiunge nel film sulla Rolling Thunder Revue una fugace love story mai davvero avvenuta con una giovanissima Sharon Stone nei panni di incantata groupie, turbando tutti gli stupidi veristi, incapaci di comprendere l’operazione e forse la stessa arte dylaniana).
«I tried ad I failed/ And I feel like going home». (Charlie Rich)
Il contesto può spiegare molte cose, non tutto. Alla fine, nella storia, si verifica sempre qualcosa di imponderabile, inesplicabile, misterioso. Questo qualcosa ha spesso a che fare con delle personalità specifiche e magiche che percorrono il sentiero tra cielo e natura.
Determinate condizioni storiche possono spiegare movimenti culturali e trasformazioni del costume, non come siano venuti fuori Elvis e Dylan. Che solo all’apparenza sono agli antipodi.
Elvis è un bianco che assorbe la cultura nera in modo originale, rielaborandola. In fondo anche Dylan lo fa, su un altro versante. Non è un semplice esproprio dell’uomo bianco in danno dell’uomo nero. Elvis, senza alcuna modestia, dichiara a Sam Phillips della Sun Records di saper cantare come nessun altro. Lo stesso può dirsi di Dylan. Elvis non imita semplicemente Arthur Crudup come Bob non imita né i bluesmen di colore né il bianco Guthrie.
«Le mie canzoni sono basate su vecchi inni protestanti, pezzi della Carter Family o varianti della forma blues. Quel che succede è che prendo una canzone che conosco e semplicemente inizio a seguirla nella mia mente. È così che faccio meditazione. Molti, per meditare, si mettono a guardare una crepa nel muro o a contare pecore, angeli, soldi o cose del genere, ed è un fatto che li aiuta a rilassarsi. Io non medito su nessuna di queste cose, medito su una canzone. Ad esempio, nella mia mente seguo di continuo Tumbling Tumbleweeds di Bob Nolan mentre guido l’auto. Sto seduto o qualunque altra cosa faccio. La gente pensa che mi sta parlando e io risponda loro. Io ascolto una canzone nella mia mente. A un certo punto alcune parole cambiano e allora inizio a scrivere una canzone».
Si ruba ciò che si ama. Ed è attraverso l’arte come furto che Dylan appare modernissimo e passatista ad un tempo. Dopo quasi sessant’anni dalla contestazione che subì al festival di Newport, quei puristi dovrebbero ringraziarlo, soprattutto dopo aver ascoltato alcuni lavori degli ultimi venticinque anni come Time Out of Mind, Love and Theft, Modern Times. Se la voce del passato è giunta sino a noi, se la memoria di un’America che non esiste più, se non in maniera sotterranea, è stata conservata attraverso la sua rivivificazione, è grazie a Zimmerman.
Del resto, se ci dobbiamo fidare di Dylan, è lui stesso a proclamarlo, e dichiarare chi sia, nell’opera che ha preceduto il suo ottantesimo compleanno, quel Rough and Rowdy Ways che è forse il suo lavoro più profondo dai tempi di Oh Mercy (1989).
Qui, citando Whitman, recita:
«Do I contradict myself?/Very well then I contradict myself/(I am large, I contain Moltitudes)».
Nel corso di buona parte di questi 80 anni, Dylan ha errato da fuggiasco, ha preso le distanze da ciò che creava appena diventava tradizione, maniera, ma non ha dimenticato nulla di ciò che conta, dalle canzoni leggere ascoltate alla radio da bambino al rock and roll primordiale. Ha sempre riportato tutto a casa, sin dall’inizio, se si pensa che considerava Too much monkey business (1957) di Chuck Berry una canzone hillbilly (genere di musica dell’America rurale bianca). Si, Bob contiene moltitudini. Dentro di lui ci sono Elvis e Guthrie, Kennedy e James Dean, i tell tales di ispirazione biblica insieme ai traumi e alle ferite mai rimarginate dell’America. Il passato e il futuro. Le rime mitragliate di The Message di Grandmaster Flash e il garage sound di Psychotic Reaction dei Count Five. I rappers e i punk, suoi inconsapevoli figli. Non è poco per chi non ha mai creduto alla storia ma solo alla grazia di Dio.