Non ha volto la Napoli delle Quattro giornate. La forza che smuove la città nel settembre del 1943, contro i tedeschi, liberandola, non conosce testa, profilo e voce di un eroe protagonista, ma la pluralità di un coro greco.
Un intero popolo che ribellandosi a rastrellamenti, esecuzioni, saccheggi e miseria, indossa il viso di uomini, donne, bambini, senza differenza di classe, quartiere e pensiero politico perché “si vulite ‘a pace amma fa’ guerra, fernite ‘e chiagnere, ascite”.

E spiegare quei giorni, come scrive Roberto De Simone in Satyricon a Napoli ’44 (Einaudi, 2014), non è facile. Non solo perché “non ci furono né un piano preciso, né un unico coordinatore”, ma perché la disubbidienza napoletana all’autorità è una categoria umana che negli ultimi anni è diventata frontiera, mischiandosi alla criminalità nei casi peggiori, venendo etichettata in tutta fretta, a volte, dagli osservatori meno attenti.
Ma un’unica regola al terzo anno di conflitto entra in vigore da via Foria a Piazza Carlo III, dal Vomero al Maschio Angioino: “A noi le guerre non ci piacciono, e insomma i tedeschi se ne devono andare”.
Donne, bambini e femmenielli
È così che donne come Maddalena Cerasuolo imbracciano il fucile, andando casa per casa per trovare fiaschi da trasformare in molotov – come racconta nel documentario di Alessandro Scippa, Barricate, 1995 -, i femmenielli del Rione San Giovanniello si uniscono ai partigiani, i bambini come Gennaro Capuozzo lanciano bombe a mano contro i carrarmati. E se donne tedesche come Eva Schmitt si impegnano a evitare la deportazione di centinaia di uomini, anche suore come madre Maria Cristina, raccontata sempre nel Satyricon, nascondono e accolgono fuggiaschi, mentendo a oltranza ai militari: “Eroicamente, poggiando le mani sui piedi di Cristo, giurò, rendendo lo spergiuro esemplare testimonianza di santità”.
Spergiuro, menzogna, furto, anche omicidio, la città vive in un capovolgimento dove la legge imposta non vale, lo Stato non esiste e “il re se n’è scappato eroicamente a Brindisi”. Solo il diritto naturale, la conservazione della vita umana ha importanza. La disobbedienza è l’unica regola. Così quando il colonnello Scholl “un nazista dei più implacabili”, dopo l’8 settembre, emana il reclutamento di tutti gli uomini a Napoli dai diciotto ai trentadue anni, la città intera si solleva.
Il documentario di Nanni Loy
Ed è un romanzo collettivo che invade l’inquadratura di Nanni Loy nel film omonimo del 1962: non c’è spazio nei titoli di apertura neanche per i nomi dei protagonisti – Gian Maria Volonté, Lea Massari, Aldo Giuffré, solo per citarne alcuni – ma poche righe di ringraziamento per gli attori che hanno partecipato in forma anonima, “in omaggio al Popolo napoletano, vero interprete delle Quattro Giornate”.

E Loy gioca a recuperare ed emulare la coralità di un film di Vittorio De Sica, Il giudizio universale (1961), sottraendo Napoli dall’atmosfera surreale scritta da Cesare Zavattini, per lasciare spazio al dramma come alle speranze di ognuno dei personaggi.
Ma nonostante Le quattro giornate di Napoli sia una testimonianza e un omaggio ai duemila civili che espulsero con le loro forze l’esercito tedesco, il film diventa allo stesso tempo un dizionario di cultura napoletana: dai commenti a Radio Londra ai saluti tra deportati – “Buongiorno ingegnere. Buongiorno avvoca’” – che sanno mettere in evidenza l’ironia, fattore imprescindibile per cui Napoli non dimenticherà mai come sia facile saper perdere, ma soprattutto la transitorietà dell’esistenza.
Con le barricate in ogni vicolo, l’assenza di un capo a cui rispondere, l’autogestione delle forze armate, improvvisate e scarse, sono in tanti a chiedere nelle scene “Scusate, ma dov’è la guerra?”.
La guerra anomala dei napoletani
È così che anche la resistenza al nazismo a Napoli, come ogni cosa, muta in anomalia. “È una guerra che si sposta”, non conosce limite di tempo, età e spazio. Si combatte dai tetti delle case, abbattendo i cecchini, ai sotterranei della città in cui si nascondono i rifugiati, si disobbedisce al coprifuoco, e soprattutto si combatte evadendo dalle carceri, svestendo e disarmando i tedeschi, come delle formiche.
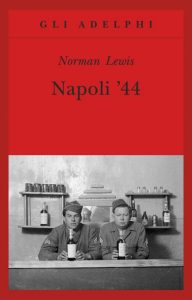
È Norman Lewis a descrivere nel suo libro/reportage Napoli ’44 (Adelphi, 1978) come agiscono gli scugnizzi nei quartieri. Arrivato da soldato britannico qualche giorno dopo la fine delle Quattro Giornate (“Napoli odora di legno bruciato”), a Posillipo si ritrova a “osservare il metodico smantellamento di un semicingolato tedesco in panne da parte di un gruppo di ragazzini, che se ne allontanavano trasportando, come tante formiche operaie, pezzi di metallo di ogni forma e dimensione”.
Un ingegno bestiale contro una forza disumana, senza peccare di organizzazione e velocità. Ed è così che Napoli costringe alla fuga in quattro giorni l’esercito che verrà sconfitto dal resto del mondo in sei anni.
Come descriverà Eduardo De Filippo il suo teatro, anche per la sua città vale la regola della creazione: “Tutto ha inizio, sempre, da uno stimolo emotivo: reazione a un’ingiustizia, sdegno per l’ipocrisia, solidarietà e simpatia umana, ribellione contro leggi superate, sgomento”.
Che cosa è rimasto oggi?
E ottant’anni dopo, gli sgomenti di Napoli non sono affatto finiti. Nella transitorietà che la contraddistingue hanno preso nuove forme, spostando per l’ennesima volta il confine tra luce e ombra, giusto e sbagliato, realtà e menzogna.
In un’evoluzione pasoliniana, il vecchio e antiquato fascismo ha lasciato il posto alla dittatura della transazione, vestendosi d’innocenza, in opportunità del territorio, tra investimenti e speculazioni, sottovalutando lo smarrimento di un popolo che conosce la sua forza ma non sa che farsene, se non sprecarla per autodistruggersi.
E probabilmente invece di celebrazioni nei giorni del calendario, alla presenza di autorità e scrittori, cantanti e djset, l’unico modo per riconoscere e rinnovare la Napoli delle Quattro Giornate, sarebbe una rieducazione a quella forza che non conosceva gerarchia e reverenza, ma solo giustizia e buon senso.
Perché è vero che “la memoria del vedere o dell’aver visto non ha confronti con la memoria del dire che è mutevole nel tempo”, ma Napoli insegna che lo spazio per l’anomalia può sempre trovarsi.
Qualcosa che si potrebbe chiamare speranza, umanità, libertà.
















