“Con un tubo nel naso per respirare, avvolto in un lenzuolo e immobile su una barella, fui spinto attraverso il nostro appartamento, poi dentro l’ascensore, attraverso l’atrio, oltre il portiere, sul marciapiede, all’aria aperta per un attimo e poi dentro l’ambulanza. Fu così che finì la mia vita. E incominciò la mia morte“.
Harold Brodkey, scrittore e giornalista statunitense nato nel 1930 da genitori russi di origine ebrea, morì di AIDS nel 1996, tre anni dopo la diagnosi.
Aveva contratto la malattia probabilmente in seguito ad alcune relazioni omosessuali del passato, tra gli anni Sessanta e Settanta.
Il racconto della propria morte
In un lucido memoriale (Questo buio feroce. Storia della mia morte) diviso in sette parti che corrispondono a diverse stagioni (da “Primavera 1993” a “Tardo autunno 1995”), condivide con i lettori quella che è l’ultima storia che gli resti da scrivere. La storia della sua morte.

Preceduta da un declino rapido all’esordio, poi lento, quindi nuovamente rapinoso, man mano che i sintomi scatenati dal virus e controllati a fatica dai farmaci allora disponibili si sovrappongono fino a togliergli del tutto il respiro. Letteralmente, visto che il primo ricovero urgente in ospedale avviene in seguito a una polmonite da Pneumocystis carinii che quasi lo uccide.
“Poi, mentre giacevo in quella stanza, vidi la cosa in modo diverso: insomma – dissi al mio medico, Barry -, si tratta solo di morire, non è come perdere i capelli o restare in bolletta. Se non altro, non devo vivere con questi problemi“.
Brodkey decide che per l’impresa intellettuale definitiva, narrare senza autocompiacimento la propria dipartita, sia necessaria una rigida disciplina: gli anni trascorsi e scanditi da conquiste, private e pubbliche, in cui nulla gli è stato regalato o concesso con indulgenza, e i mesi che restano, dopo la prognosi onesta dei medici a cui si affida.
La moglie Ellen al suo fianco
Figlio di un pugile semiprofessionista ignorante e violento, Brodkey – cognome dei parenti a cui il padre lo vendette per trecento dollari – ha attraversato la giovinezza e l’età adulta con la mitologia della lotta per ottenere, spesso in modo precario, un posto al sole.
Ci provano in molti, certo, ma i più, per le circostanze o la mancanza di capacità o entrambe le cause, rimangono in un cono d’ombra. Sotto la cappa del silenzio. Ed è proprio il pericolo del tacere che adombra il cuore e i pensieri dello scrittore: la vita è di per sé ininterrotta sottrazione e non puoi opporti, lei stessa ti costringe alla resa e alla contemplazione della perdita. La parola, no: se evapora il filo che permette agli umani di scambiarsi opinioni e risate lievi o anche duri conflitti e giudizi sprezzanti, ecco, quello è inaccettabile inferno.
“Talvolta mi intristisce che sia finita, ma solamente per i libri, i tramonti e le conversazioni“.
I libri, i cari amici morti e più che mai vivi. Sempre con sé, adagiati sulla pancia mentre trema di febbre rintanato sotto il piumone o quando in una camera asettica d’ospedale attende un prelievo, l’internista che lo informa sulla conta dei linfociti T o la moglie Ellen, uno scricciolo di quarantasette chili che lo gira e lo sistema e previene con i suoi abbracci, di colpo forti come acciaio, le piaghe da decubito.
Libri su di lui e fra di loro. Parole alate e vane, parole che restano. Quando il respiro sta facendo i bagagli con un biglietto di sola andata, lo scrittore annaspa e rimpiange le novità editoriali che non potrà conoscere, i classici che non saranno da lui recensiti, i diari che rimarranno privi di aggiornamento.
La nostalgia per le conversazioni e i tramonti
I tramonti, anche. Pare retorico, invece è così foscoliana e a ogni umano nota l’esperienza irripetibile di cercare con gli occhi il sole. Mentre si muore, ovvio. Ma anche mille volte prima, mentre si scivola, a partire dalla nascita, verso il buio. Quello “feroce” del titolo. Quello che segnerà la cesura fra i crepuscoli sul fiume Hudson e il nero e basta.
Nemmeno una sfumatura a definirlo. E, di nuovo, le conversazioni. Brodkey ne intuisce già la mancanza. Perché conversando o litigando e facendo la pace di fronte a una birra fredda si sentiva parte di una comunità. Avvertiva un senso di compimento.
L’esistenza, ripensandola mentre compila il resoconto dei giorni, più o meno buoni, che il virus colonizzatore gli concede, è un continuo richiamo a una vitalità incontrollabile e confusa.
Non si è risparmiato, Harold, nemmeno in una fase circoscritta di curiosità pansessuale che lo ha portato nel reparto infettivi dove si trova ora. Nessun senso di colpa né rimpianto; l’unica paura è quella, pur a distanza di anni dalle sue ultime esperienze promiscue, di avere contagiato la moglie. Ellen risulterà negativa al test e piangerà perché “la deprimeva essere così separata da me”.
Una reazione emotiva, niente che l’assurdo magma psichico dell’amore non possa comprendere. Se non spiegare. Lo scrittore americano tra le pagine dà spazio a molto altro, non soltanto alla patologia e alle infezioni ricorrenti che l’immuno-depressione comporta: una vita intera non si definisce con la sua finitezza o il motivo che la sancisce.
In fondo, riflette l’autore con autoironia, questi sono dettagli. Conta la riflessione sulla coscienza di come e dove si è stati nel mondo: il ruolo ottenuto, l’immagine fornita, la memoria di sé.
La grandezza di Brodkey
Brodkey è uno scrittore e non un pennivendolo come tanti, semplicemente perché ciò che produce è sempre alta letteratura, anche quando la riflessione è autocentrata. Assenti il tedio o la prevedibilità nei capitoli che scandiscono i mesi: è arte destinata a restare, perché essa è la cifra che definisce il talento e lo innalza sull’altrui mediocrità.
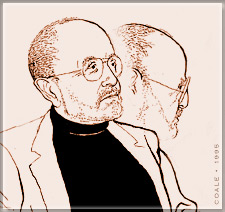
Molti si illudono di essere narratori, pochi hanno diritto a un sedile comodo nella turris eburnea della parola. Brodkey era già assiso lì da vivo, morire è solo una metamorfosi.
Harold fissa il quotidiano e lo straordinario e rende ogni aneddoto o riflessione interessanti come se non fossero mai stati uditi prima. Gli scrittori che possono definirsi tali hanno un dono: ogni parola che fermano sulla carta pare inedita e leggendoli si rimuove per un attimo il multiverso di milioni di sillabe concepite da Omero in poi.
Apri il memoir di Brodkey e trovi anche altro: filosofia e politica, la sessualità repressa della Grande Mela e la tentazione orgiastica che ne consegue.
Scopri la ferocia delle relazioni competitive in una megalopoli che ha il culto del successo e la poesia del traghettare lento verso Liberty Island. Ti dimentichi, sfogliando le pagine, che l’autore sta morendo di AIDS.
Un memoir che non lascia indifferenti
Brodkey non intende essere didascalico, non ha lezioni da impartire o nulla in extremis da imparare. Solo una storia, semplice e risaputa e condivisa dai lettori, perché trattasi di esperienze universali. Il racconto della sua vita e della sua morte. Una parabola banale, in fondo.
È l’arte oratoria a tracciare il solco e a evidenziare le differenze. Harold non censura alcun dettaglio, descrive i giorni e le notti a modo suo. Può piacere o meno, ma non lascia indifferenti.
Questo buio feroce non cela l’indicibile o i presunti comportamenti scandalosi che l’io narrante rivendica con orgoglio. Si chiama libero arbitrio, le conseguenze vengono affrontate e il dazio a Caronte lo paga chi muore.
Non chiede prestiti o lacrime di finto compatimento. Domanda partecipazione, quella sì: Brodkey squaderna in sette macrocapitoli una furiosa volontà di esibizionismo, la seduzione, l’ambiguità dei sentimenti e il gusto per la comoda vita borghese che lo ha segnato fin dalla faticosa infanzia.
Il libro diventa la sua lapide, un viaggio nei labirinti dell’emotività e una dichiarazione di assoluta passione per la compagna, che mette in scena con lo sguardo di un innamorato colto di sorpresa di fronte alla bellezza delicata della donna e alla costanza con cui gli rimane accanto.
Lo stile di Brodkey, nonostante il duro tema affrontato, non evoca angoscia né dolore perché più che mai in quei mesi di stesura la sua penna fu attraversata da una grazia illuminata dalla comprensione. Verso se stesso e gli altri.
Si immerge con sapienza nel cuore come farebbe un sommozzatore: si muove con cautela, schiva ostacoli ma si concentra sui prodigi colorati della barriera corallina o spinge lo sguardo dentro i meandri di una grotta oscurata da manciate di anemoni.
Sfiora con delicatezza il porto sepolto immaginato dal poeta, sa che da qualche parte c’è un forziere che trabocca diamanti e monete auree. Solo chi sprofonda nella città fantasma dell’anima può e deve riportare alla luce il tesoro. Distribuirlo.
“La vita è una specie di orrore. Nemici e ladri non demordono mentre ti indebolisci, è proprio allora che i malvagi prosperano insistendo nella loro crudeltà“.
Il parallelo con Manzoni
L’amara consapevolezza che lo coglie, a volte, ripensando alla debolezza e al rapido dimagrimento dei mesi precedenti la diagnosi, fa pensare alla notte cupa dell’Innominato, che non sta morendo di un morbo fisico ma è in procinto di soccombere al veleno dello spirito, alla tentazione del suicidio.
Fra le immagini che fermano il personaggio manzoniano un attimo prima di spararsi un colpo prevale quella dei nemici e dei falsi amici che godranno della sua dipartita. Forse banchetteranno sul suo cadavere, magari ne faranno scempio. Restare qui e ora, nonostante l’orrore e la solitudine di cui anche Brodkey ha contezza, è l’unica scelta matura.
La fuga non è contemplata, rimane il tempo del fare, del ricostruire o del creare fino all’ultimo respiro. Prima dell’asfissia definitiva, Brodkey desidera trascorrere alcuni pomeriggi estivi presso la casa di campagna, osservare Ellen impegnata a curare le piante, a zappare e a seminare: “I ricordi dei giardini, le verdi incarnazioni di idee che i giardini esprimono sono cose a cui ricorro per alleviare le ore difficili“.
La parabola così simile di Hitchens
Il libro di Brodkey ne ricorda uno simile pubblicato diversi anni dopo, postumo, nel 2012: Mortalità, di Christopher Hitchens. Una raccolta di saggi, scritti per Vanity Fair, in cui l’autore racconta la diagnosi del proprio tumore in fase terminale e, mentre descrive gli effetti collaterali delle ormai inutili terapie e attende impaziente che un’elevata dose di protoni gli attraversi gli organi “a una velocità pari a due terzi di quella della luce“, cita Auden che, in 1 settembre 1939, scrive: “Tutto quello che ho è una voce“.
Di nuovo, la voce. Il terror panico non della fine imminente ma di una peggiore morte, quando ancora si è clinicamente vivi: la perdita dell’abilità di scrivere e di conversare, la gioia di individuare nel lògos il reale, se ne esiste uno, significato dell’esistenza.
Anche lo stile di Hitchens fu definito cristallino e granitico, senza sbavature. La scrittura perfetta per mantenere una voce impegnata a sconfiggere i più temuti nemici, l’ottusità del silenzio e l’omertà del soffrire.
Si può spiegare il caos?
Il senatore romano Severino Boezio, vittima di un complotto nel 524 d.C., imprigionato a Pavia e in attesa dell’esecuzione, compone un fulgido prosimetro da lasciare in eredità al mondo e lo conclude così: “Se non volete sottrarvi alle vostre responsabilità, non potete ignorare la profonda esigenza di onestà che è riposta in voi“.
Brodkey, Hitchens e Boezio, separati dal tempo i primi due e anche dallo spazio nel caso del filosofo amato da Dante, intrapresero viaggi diversi ma condivisero la meta: quando tutto è stato detto e fatto e compiuto e si conosce o si intuisce con buona approssimazione, come a loro accadde, la data del congedo, l’onestà è il solo testamento da redigere.
Essere testimoni e provare a spiegare il caos, dargli forma ove possibile, inserirlo tra righe ordinate in un codice sfilacciato o in un menabò pronto per la stampa. L’onestà bussa alla porta e chiede udienza. La responsabilità è sua sorella. Le parole scelte con cura sono ancelle leali.
E di quel “nulla d’inesauribile segreto” sia colmo il naviglio su cui, presi per incantamento, un giorno, insieme e soli, entraste nell’alto passo.
Noi seguiremo la via, rotolando lievi e lieti sulla Via Lattea. Dove i giusti e Scipione hanno allestito il banchetto. E, colmo il cratere, attendono.
















